28 nov 2025Tempo di lettura: 23 min


2 nov 2025Tempo di lettura: 34 min


13 lug 2025Tempo di lettura: 5 min
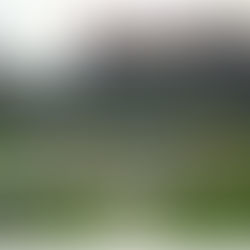

4 apr 2025Tempo di lettura: 6 min


16 mar 2025Tempo di lettura: 29 min




Versione PDF stampabile:

Questo film è senz'altro uno degli esempi più fulgidi di come l'arte serva per scuotere la coscienza come un terremoto che sancisce un prima e un dopo. E lo fa mostrando l'orrore che si cela davvero dietro la "banalità del male" (Arendt, 1963), situando l'abominio dell'indicibile al di là del capo di ripresa, senza ricorrere nemmeno per un attimo alla pornografia del cruento, al voyeurismo del macabro, dell'agonia, del sangue. Eppure questo film lascia uno strazio che non si riesce più a scrollarsi di dosso. Un dolore in grado di toccare la parte più profonda della propria umanità, mentre urla disperatamente per essere ascoltata, nonostante l'insostenibile peso dell'orrore. Perché è proprio attraverso i suoni (come per la musica cacofonica inserita) che l'orrore si insinua nella coscienza bucando quelle immagini analmente geometriche, ordinate, pulite, così noiose da potere essere uscite da un film di Buñuel. Grida, rumori di spari, lamenti, cani che abbaiano, treni in arrivo... si aggiungono a tutti quegli elementi (le ceneri che inquinano il fiume, l'odore acre dei cadaveri bruciati, le fiamme di notte che illuminano le finestre delle camere da letto...) che continuano perentoriamente a disturbare la costante opera di diniego adoperata dai personaggi per non lasciare entrare in casa l'aberrante atrocità che sta avvenendo.
Eppure, come si sa, quando si sbarra la porta principale della coscienza, allora tanti intrusi cominciano ad invadere casa attraverso le brecce dell'inconscio: la ragazzina inquieta e turbata che di notte non prende sonno e gironzola per casa, il sadismo tra fratelli nella scena della serra (Haneke docet), il conato senza vomito di Höß alla fine del film (dove almeno il corpo, scisso completamente dalla mente, non è in grado di nascondere, anche solo per un attimo, la reazione all'orrore)... finchè un rosso sangue della corolla di un fiore non invade per qualche istante tutto lo schermo come un sintomo che sparge panico nello spettatore.
E se nella madre della "regina di Auschwitz" (per quanto si affretti a chiudere le finestre di casa per non fare entrare le ceneri dei camini) la negazione cede il passo all'evitamento, solo nei fotogrammi catturati con le telecamere termiche ad infrarossi che ritraggono una domestica ebrea della casa nascondere cibarie nel campo di concentramento, rimane l'ultimo residuo di umanità e di coscienza (non a caso Freud [1905] diceva che la nevrosi è il negativo della perversione, specularmente alle immagini "in negativo" proposte). Ciononostante, il tanto ambito benessere delle mura domestiche deve continuare a prosperare a qualsiasi costo, come nella scena emblematica in cui una Hedwig indispettita brucia nella stufa il biglietto di commiato della madre.

La potenza di questo film consta nella fortissima dissonanza che permea ogni scena, sottolineando la dimensione dissociativa, scissa, ossimorica che sottende la psiche dei personaggi. Il forte contrasto creato dall'alternanza tra gli ambienti superiori, a volte così luminosi da disturbare, dove tutto sembra quadrare in modo farsesco (gli esterni, il salone della festa di promozione...), ed i piani inferiori, chiusi, claustrofobici, da cui gradualmente escono gli scheletri nell'armadio (come i sotterranei labirintici o le rampe di scale della scena finale). Il padre di famiglia che legge le favole della buonanotte ai figli piccoli è il medesimo che progetta con zelo e passione il modo più efficace per incenerire gli ebrei oltre il sottile muro che divide l'inferno in terra dal giardino lussureggiante dell'Eden (come i dipinti di L. Cranach). La stessa cenere dei morti mandati poco prima alle camere a gas viene impiegata per concimare la terra e donare bellezza ai fiori del giardino: la vanità di una misera famiglia borghese che fiorisce grazie allo sterminio che si sta perpetrando accanto.
E questa dissonanza disturbante non fa che rimandare alla solita domanda: com'è possibile tutto questo? Arendt (1963) ha sottolineato il ruolo del contesto socioculturale nel plasmare coscienze prive di senso critico e di responsabilizzazione, creando automi quasi privati di volontà propria; Milgram (1974) ha mostrato come il solo ruolo dell'obbedienza cieca all'autorità possa produrre i peggiori comportamenti; Miller (1987) ha scandagliato il passato di Hitler e dei gerarchi nazisti attribuendo a questo (la "pedagogia nera") la principale responsabilità delle loro azioni future; Chasseguet-Smirgel (1986) ha visto nella ricerca del Führer (per quanto folle) il bisogno simbiotico di un popolo alla deriva alla ricerca di una madre onnipotente a cui sottomettersi completamente; Fromm (1973) ha osservato come fosse la massiccia presenza di aspetti necrofili ad aver caratterizzato gli autori delle atrocità commesse.
Il regista Glazer ci ha tenuto semplicemente a mostrare come tutto ciò, a ben vedere, sia tutt'altro che qualcosa di alieno rispetto alla natura umana. Anzi, questi uomini così spudoratamente senza coscienza, così piccoli e così capaci di crudeltà non vengono ritratti come dei mostri, ma come persone cosiddette "normali" immerse negli stessi miseri problemucci quotidiani ed esistenziali della gente comune. In altre parole il regista ci ammonisce, a ben vedere, che quel "loro" in realtà è un "noi".
Non ero interessato a fare un pezzo da museo. Non volevo che la gente avesse una distanza di sicurezza dal passato e se ne andasse senza restare turbata da ciò che aveva appena visto. Volevo dire che dovremmo sentirci profondamente insicuri per questa sorta di orrore primordiale che ci riguarda tutti. (...) Ero determinato a non fare un film sul passato ma sull’oggi perché questo non è un documento. Non è una lezione di storia. È un avvertimento. (Il regista J. Glazer)
Perché se La zona d'interesse ci parla così direttamente e violentemente è soprattutto perché tutto ciò ci riguarda da molto, molto vicino. Le risate delle feste nel giardino tra un tuffo e l'altro in piscina sullo sfondo della coltre di fumo degli inceneritori sembrano speculari alle serate festose degli israeliani mentre si scattano selfie sullo sfondo dei bombardamenti in atto sul territorio palestinese, o alle gite turistiche a prezzi stellari organizzate per spettacolarizzare i luoghi martoriati dalle bombe.
Mentre si sta compiendo un genocidio, il mondo continua a vivere come la famiglia nazista del film, tra l'indifferenza, le priorità solipsistiche del proprio narcisismo e le facezie di una quotidianità improntata su logiche piccolo-borghesi che sembra l'unica realtà esistente. E questa tragedia mondiale continua a venire affrontata nella negazione generale di ciò che sta accadendo a spese di una perdita crescente di quel briciolo di umanità rimasta (perché ai tempi della globalizzazione, è impossibile ormai difendersi con l'evitamento o con la rimozione). Altrimenti, tra l'impotenza pervasiva nell'osservare la medesima inerzia anche da parte delle potenze mondiali, non rimane che farsi carico del male e del dolore che sta subendo quel popolo massacrato, perché, dicendola alla Hillman (1992), se il mondo stesso è malato e sofferente, anche noi non possiamo di certo uscirne immuni. Proprio come tutto quel dolore che tocca provare allo spettatore al posto dei personaggi del film, così incapaci di vedere nell'altro anche sé stessi.
Ed è proprio questo lo scopo del regista: accantonare ogni narrazione, retorica, sentimentalismo, intrattenimento e musealizzazione per destabilizzare, chiamare in causa e arrivare dritti al punto... con la speranza di ricondurre l'uomo alla propria umanità smarrita.

Arendt H. (1963). La banalità del male. Feltrinelli, Milano, 2013.
Chasseguet Smirgel J. (1986). I due alberi del giardino. Feltrinelli, Milano, 1991.
Freud S. (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, Opere vol. IV, Boringhieri, Torino 1970.
Fromm E. (1973). Anatomia della distruttività umana. Mondadori, Milano, 1975.
Hillman J. (1992). Cent'anni di psicoanalisi e il mondo va sempre peggio. Adelphi, 2022.
Milgram S. (1974). Obbedienza all'autorità. Uno sguardo sperimentale. Einaudi, Torino, 2003.
Miller A. (1980). La persecuzione del bambino. Le radici della violenza. Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
Il Blog, che riceve migliaia di visualizzazioni giornaliere, contiene articoli coperti da diritti d'autore, ognuno dei quali proviene da mesi di scrupolose ed estese ricerche sul tema. Ciononostante si è scelto di divulgare tali studi in maniera completamente gratuita, senza la necessitò di affiliazioni obbligatorie ad istituzioni o riviste ed escludendo qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria. Si prega pertanto di fare buon uso di tale materiale, con l'augurio che tali contenuti possano rappresentare una fonte di stimolo per chiunque abbia interesse ad esplorare tutto ciò che riguarda quel curioso e misterioso fenomeno che è l'essere umano.
Commenti