28 nov 2025Tempo di lettura: 23 min


2 nov 2025Tempo di lettura: 34 min


13 lug 2025Tempo di lettura: 5 min
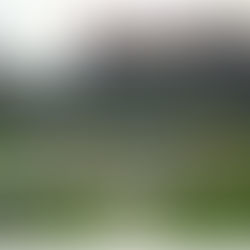

4 apr 2025Tempo di lettura: 6 min


16 mar 2025Tempo di lettura: 29 min




Versione PDF stampabile:

Se parli con Dio, stai pregando; se Dio parla con te, sei schizofrenico. (T. Szaz)
Fu lo psichiatra Eugène Bleuler, nella sua famosa opera del 1911 sulla dementia precox (termine derivato da Emil Kraepelin), ad introdurre il termine "schizofrenia" (mente scissa, separata) e ad annoverarla tra le varie forme di psicosi (come quella maniaco depressiva e paranoidea), sottolineandone il carattere frammentario (Spaltung), divisorio, dissociativo, disgregato.
Se Freud scriveva che il pazzo non è altro che un sognatore sveglio è perché in effetti lo schizofrenico sembra davvero vivere in un mondo diverso da quello delle cosiddette persone "normali", ossia in quella realtà alter appartenente all'inconscio e alle sue bizzarre leggi, di cui ognuno di noi ha esperienza ogni notte quando sogna. E' come se nella psicosi la persona avesse smarrito in buona parte la linea di demarcazione tra il mondo diurno e quello onirico (come se l'Io si dissolvesse nell'Es, secondo la terminologia classica), o in altri termini, come se fossero venute meno le difese rispetto a quei contenuti più primitivi e caotici della psiche umana che cadono sotto il nome di follia. La stessa esperienza allucinatoria, che evidenzia seri disturbi nel campo senso-percettivo, rimanda all'etimo latino alucinor, che significa divagare, sognare, vivere, come nel mondo dei sogni per l'appunto. Anche se sarebbe più corretto parlare di incubi, dato che la psicosi (che non equivale quindi alla follia, anche se vi attinge nelle sue manifestazioni) rappresenta una risposta difensiva (forse l'ultima a disposizione dall'Io, per quanto altamente costosa in termini funzionali), contro il rischio di abissamento in quel caos primordiale che abita l'inconscio. Ivi egli ingaggerà durante tutto il processo morboso una lotta disperata per non venire inghiottito nuovamente dal grembo materno, la matrice originaria da cui egli non riesce a differenziarsi (per approfondimenti...).
Sebbene la psiche di ognuno conservi sempre aspetti psicotici (per approfondimenti...), la schizofrenia come quadro patologico finisce per diventare una sorta di disfatta (Federn, 1956), una sconfitta di un Io che ha dovuto fare i conti con una rottura, e lo schizofrenico, nella tragica esperienza di una realtà interiore sempre più in frantumi, appare come un individuo smarrito nel mondo, il quale, nell'impossibilità di vivervi, ha dovuto crearsene uno proprio (Resnik, 1986). In altre parole, la schizofrenia porta ad una frattura netta tra un prima e un dopo, siccome la visione del mondo della persona può risultare talmente mutata da essere vissuta come una "catastrofe interiore" (Freud, 1911) in una realtà sempre più sconosciuta e incomprensibile. Eppure, per quanto possa sembrare strano, anche il processo psicotico rappresenta il tentativo inconscio da parte del soggetto (forse il più radicale) di distruggere vecchie strutture precarie per erigerne delle nuove proprio partendo dalle fondamenta, ovvero dalle zone più profonde e arcaiche del proprio Sé (Jung, 1904).
Lo schizofrenico deve mantenersi in equilibrio su una linea sottile, coltivando sia un legame surrettizio con la sanità mentale e il mondo esterno sia, evidentemente, una relazione intima con la sua nuova realtà allucinogena.(Bollas, 2015, p. 125)
Sebbene nel DSM-V siano scomparse le categorizzazioni della schizofrenia, lasciando spazio ad un continuum dello spettro schizofreniforme (disturbo schizoide, disturbo schizotipico, disturbo schizoaffettivo, disturbo delirante, disturbo psicotico breve, disturbo schizofrenico, etc.), trovo ancora utile da un punto di vista descrittivo conservare le classiche nosologie psichiatriche (Arieti, 1955): la forma semplice, che è senza sintomi positivi; quella paranoide, caratterizzata prevalentemente da temi paranodei (idee di riferimento, eco del pensiero, deliri di persecuzione...); quella ebefrenica, considerata la forma più grave, disorganizzata, manieristica, regredita; e quella catatonica, con le sue tipiche manifestazioni (catalessia, stupor, grimace, ecoprassie, ecolalie, negativismo, stereotipie, ecc.).
Arieti (1955) ha distinto quattro stadi del decorso della malattia. Nel primo stadio il soggetto prova un periodo di grande angoscia e panico, seguito da un'immediata confusione e senso di smarrimento, finché non compare l'"insight psicotica": l'improvvisa sensazione epifanica che ogni cosa, come in un lampo improvviso, acquisti una nuova luce, un significato globale in base ad un nuovo sistema di pensiero. Dopodiché compaiono i sintomi della schizofrenia (deliri, allucinazioni, manifestazioni catatoniche, idee di riferimento, ecc.) e la regressione può passare da una forma all'altra della fenomenologia schizofrenica, prima di stabilizzarsi nel tempo. Nel secondo stadio la persona sembra aver "accettato" la propria malattia: l'angoscia pare essersi ridotta e deliri e allucinazioni non vengono più contrastanti con intenzioni pseudo logiche. Nel terzo stadio deliri e allucinazioni sono quasi scomparsi o, se ancora presenti, sono privi di carica emotiva, motivo per cui in questo stadio preterminale i quattro tipi di schizofrenia sembrano assomigliarsi tra loro. Il malato presenta una grave disintegrazione dei processi cognitivi, il linguaggio diventa incomprensibile ed egli inizia a sviluppare abitudini particolari come quella di adornarsi o accumulare oggetti. Al quarto stadio prima si assiste ad una diminuzione generale dell'attività e in seguito, nei malati che continuano a regredire indefinitamente, si riscontra un aumento più o meno improvviso dell'attività motoria che perdura per tutta la vita. In questo stadio essi non sembrano più capaci di deliri o di allucinazioni e la loro comunicazione verbale diventa completamente assente o fatta di poche frasi sconnesse. Il distacco dal mondo è tale che essi arrivano a manifestare un'insensibilità al dolore e alla temperatura.
Similmente Pao (1979) ha distinto tre fasi nel decorso della malattia schizofrenica: la fase acuta che comincia con l'esplosione dei sintomi, dove l'Io, in preda al terrore, affonda in una regressione profonda; la fase subacuta, nella quale la persona comincia a ristrutturare il proprio Sé e il mondo oggettuale, e il proprio terrore diminuisce; la fase cronica, in cui l'alterazione che ha subito il Sé diventa progressivamente inalterata e fissata nel tempo.
Tutte le difese sono ormai cadute o sono state giudicate inutili, e il malato è incapace di far fronte al suo stato di ansietà. [...] Egli non può più venire a patti con la realtà; ora deve cambiare la "realtà". Potrà farlo entrando nella psicosi. (Arieti, 1955, p. 78)
Come è risaputo, escludendo cause direttamente organiche o legate a malattie neurologiche, la schizofrenia si manifesta prevalentemente durante l'adolescenza o poco più tardi durante la prima età adulta. Come ha evidenziato Pao (1979) infatti, anche nei casi in cui sintomi schizofrenici compaiono in tarda età, ad un attento esame anamnestico è possibile rinvenire anche durante l'adolescenza una storia prepsicotica fatta di episodi psicotici, per quanto brevi e contenuti, o perlomeno di disturbi progressivi delle funzioni dell'Io prima dello scatenarsi di sintomi più invalidanti. Periodo in cui non di rado è possibile rintracciare nel giovane adulto tutta una serie di frenetiche attività (come l'uso di sostanze, promiscuità sessuale, aspri contrasti coi genitori...) volte a dominare intensi conflitti che, in assenza di risoluzione con la realtà esterna, andranno ad indebolire gradatamente l'Io fino a farlo collassare nell'esordio psicotico. Oppure non di rado nel giovane prepsicotico possono comparire tutta una serie di sintomi ossessivi-compulsivi di carattere generale o un'ipocondria generalizzata volti a spostare sul soma la crescente ansietà interiore. Da un punto di vista cognitivo la persona cerca di trovare una logica e una spiegazione soggettiva ai nuovi fenomeni che lei stessa riconosce come irrazionali e strani. Anche i sogni di prepsicotici spesso possono far presagire l'imminente malattia attraverso immagini di terribili catastrofi, fine del mondo, crolli del terreno, vortici violenti, apocalissi, etc. (Jung, 1958)
Tuttavia, il modo in cui inizia una psicosi conclamata è assai variabile, in quanto in alcuni casi l'inizio è lento, insidioso e passa quasi inosservato, in altri essa si verifica in modo acuto, improvviso, acutissimo.
Chi si avvicina ad un esordio schizofrenico sperimenta profondi cambiamenti in tutto il proprio essere, come una specie di trasformazione: può avere alterazioni percettive (una strana vividezza dei colori, una diversa percezione delle forme e delle dimensioni, una particolare sensibilità rispetto alla luce o a certi rumori), alterazioni motorie (camminare o muoversi in modo diverso, certe stereotipie nei gesti, nelle posture o nelle azioni), alterazioni comunicative (linguaggio criptico o incomprensibile), alterazioni comportamentali (ritiro, rigidità, evitamento) o ideative (pensieri bizzarri e irrazionali fuori controllo)... in generale la persona appare sempre più eccentrica agli occhi degli altri che iniziano a notare palesi cambiamenti in atto.
L'individuo sente gradualmente di stare perdendo la propria libertà, sempre più compromessa da minacce, pensieri intrusivi, voci che invadono il campo mentale. E tutto ciò, oltre che a causare un'intensa angoscia, getta il soggetto in una crescente confusione e solitudine dovute alla sensazione sempre più preminente di sentirsi alieno tra gli umani e di stare perdendo la possibilità di poter essere compresi da qualcuno.

Freud scriveva che l'Io è prima di tutto un Io corporeo: infatti è la percezione del corpo (come rappresentante dell'Io) che nello schizofrenico subisce le alterazioni più immediate. Egli sembra essere ritornato ad una primigenia modalità somatoforme in cui il Sé esperisce il mondo principalmente attraverso sensazioni corporee. Nello schizofrenico moti emotivi vengono frequentemente scambiati con sensazioni somatiche o alterazioni della struttura somatica (pesantezza agli arti, mutamenti delle dimensioni delle parti del corpo, ecc.).
Il dramma che vive lo schizofrenico è la sensazione di fatica nell'abitare il proprio Io (depersonalizzazione): perdendone contatto, la persona schizofrenica può vivere il proprio corpo o parti di esso come cose estranee a sé, per cui anche le azioni più semplici possono apparire come automatismi meccanici simili a quelli di un androide, incapace di una soggettiva volontà d'azione e di intenzione. Tausk (1919) ha descritto come nello schizofrenico possa svilupparsi l'immagine di una "macchina influenzante" fatta di congegni e ingranaggi che viene proiettata sul corpo ed è in grado di intaccare le sue funzioni, privandolo gradualmente del proprio controllo (essa può rubare il pensiero, provocare eccitazione, far fare cose bizzarre...). Le frantumazioni psichiche si ripercuotono così sul corpo che perde il proprio "ordine interiore: gli organi sono dislocati, buchi o protuberanze si formano all'interno, l'appartenenza sessuale viene rovesciata" (Bendetti, 1992, p. 108). Ecco perché Hartmann (1964) vedeva nella tipica ipocondria dello schizofrenico il tentativo di iperinvestire un Io (nelle sue rappresentazioni corporee) sempre più smarrito.
Come aveva già osservato Bleuler (1911), uno dei "sintomi fondamentali" della schizofrenia consiste nell'alterazione del processo di associazione, in cui si assiste ad una intensa alterazione dei processi formali del pensiero. In particolar modo, quando nello schizofrenico il pensiero non è ancora intaccato in modo esageratamente grave, si può notare che egli parla senza una direzione logica, collegando involontariamente i pensieri secondo semplici leggi di associazione e mancando di continuità e scopo. Con l'avanzare del processo schizofrenico, le idee tendono ad associarsi per somiglianza collegata alla verbalizzazione invece che alla connotazione (ad esempio secondo allitterazione o un ritmo fonetico simile), fino ad arrivare a mischiarsi in insalate di parole o in espressioni stereotipate e ripetitive nei casi più gravi.
Perciò nello schizofrenico il linguaggio può diventare un discorso davvero incomprensibile all'interno di quello stile espressivo astratto, disorganizzato e vago tipici della malattia. Egli infatti "cosifica" il linguaggio, (le parole diventano le cose stesse), ovvero priva il linguaggio del suo aspetto astratto, alterandone i comuni significanti, creando neologismi o usandolo in maniera indecifrabile. Il malato diventa quindi incapace di comprendere la natura metaforica del linguaggio, ad esempio non capendo più proverbi e modi di dire, che vengono interpretati alla lettera. L'ordine del simbolico viene sovvertito, dove "l'estremamente primitivo si mescola all'estremamente elaborato, in un'alleanza singolarissima di barocco e di arcaismo" (Racamier, 1980, p. 37). Infatti il paradosso dello schizofrenico è che se da una parte ha fatto dei simboli qualcosa di concreto, secondo un "pensiero paleologico" (Arieti, 1955), dall'altra egli simbolizza ogni cosa della realtà esterna, ossia tutto diventa parte del soggetto stesso. In altri termini, l'Io viene sempre più esonerato e l'inconscio si sparpaglia sul mondo. Tale processo è dovuto al tentativo disperato da parte dello schizofrenico di iperinvestire la parola laddove il senso stesso degli oggetti è stato perduto.
Con lo scompenso schizofrenico la persona perde contatto con la propria storicità: egli risulta cioè incapace di narrare in maniera cronologica e organizzata il proprio passato. Bollas (2015) parla di annullamento di una realtà personale passata tramite lo sviluppo di una "mitologia schizofrenica" che permette allo schizofrenico di creare una realtà alternativa (pur continuando ad essere popolata da mostri e demoni) che offre al proprio Sé perlomeno di strutturare e ordinare l'esperienza passata, presente e futura.
In generale, non riuscendo più a funzionare ad un livello elevato, l'Io è costretto a ritornare a livelli di funzionamento più arcaici o infantili: "quelle che a noi possono sembrare forme di irrazionalità sono invece forme arcaiche di razionalità" (Arieti, 1955, p. 179) atte a diminuire l'angoscia, seppur temporaneamente. Tuttavia, anche quando lo schizofrenico appare regredito nella maggior parte del proprio funzionamento, questa regressione non è quasi mai totale, in quanto alcune funzioni dell'Io possono rimanere intatte nel corso della malattia, siccome "c'è sempre una parte del paziente, per quanto piccola, che non accetta la psicosi" (ibid., p. 429),
Le allucinazioni (molto spesso uditive) rappresentano parti di Sé scisse ed espulse fuori che, come presenze estranee, cercano di parlare al Sé dello schizofrenico in qualità di frammenti ripudiati (aspetti dissociati) che vogliono fare ritorno per dialogare indirettamente con l'Io. Di solito le voci inizialmente provengono da oggetti inanimati per poi diventare parte stessa della mente dello schizofrenico formando una cacofonia di voci parlanti in contrasto tra loro. Similmente, il delirio (de-lira: "uscire dal solco") è un "modo inadeguato di categorizzare la realtà del mondo esterno-interno, un modo di risolvere il caos e le differenze" (Resnik, 1986, p. 18), "un modo di costruire o ricostruire una realtà a partire dai frammenti rimasti dell'esperienza catastrofica" (ibid., p. 35). O più semplicemente, una modalità utilizzata per riacquistare un rapporto, per quanto alterato, col mondo esterno (Freud, 1923).
Che siano deliri o allucinazioni, questi sintomi rimangono tentativi disperati di organizzare, gestire e dare un senso all'improvvisa e violenta inondazione dell'inconscio che ha pervaso il fragile Io, la cui aspirazione più importante è quella di sbarazzarsi di ogni conflitto. In quest'ottica tali sintomi rispecchiano un tentativo maldestro di "terapia" da parte dello schizofrenico che si trova ad alterare completamente la realtà esterna pur di mantenere un senso (seppur precario) di identità. Per quanto questi sintomi possano essere per l'individuo egodistonici, intrusivi, spiacevoli, violenti ed estranei, egli continua ad aggrapparcisi con tenacia e disperazione con una paradossale funzione protettiva. Secondo Benedetti (1992) infatti "il delirio va preso per una comunicazione cifrata rivolta all'ambiente circostante e per un tentativo del malato di dar conto di se stesso e, contemporaneamente, di celarsi" (p. 14). Attraverso esso il malato esprime e allo stesso tempo subisce (in modo intrusivo, persecutorio) un aspetto di Sé da tempo represso: se da una parte egli è vittima dei propri pensieri incontrollati, dall'altro egli, essendo il proprio persecutore, si sente potentissimo, grandioso e capace di imprimere qualsiasi affetto.
Tuttavia, come ricorda bene Bion (1967), una mente proiettata è una mente persa, in quanto l'Io, attaccando il proprio apparato percettivo, si mutila creando tanti piccoli "frammenti" che vengono incapsulati in modo dissociato all'interno del proprio Sè o che trovano un posto negli oggetti esterni seguitando a condurre "una vita autonoma ed incontrollata fuori dalla personalità" (p. 68). Perciò queste difese, per quanto "soluzioni" adottate dall'Io, con il progredire della malattia non fanno che esautorare sempre di più la mente attraverso i diversi attacchi che l'apparato psichico arreca a sé stesso (le parti odiate in conflitto). E così, a causa di questo processo costante di atomizzazione e di compartimentalizzazione, il Sé si svuota sempre di più finendo per disintegrarsi in una sorta di "disabitazione psichica" (Bollas, 2015). Similmente altri autori hanno espresso tale concetto: Federn (1956) ha parlato di perdita della realtà come conseguenza di una continua opera di estraniazione che il malato avverte a causa delle sue percezioni distorte in grado di sovrascrivere gradualmente sempre più quelle passate; Arieti (1955) indicava una "regressione che si autoperpetua" a scopo difensivo secondo più stadi di gravità crescente, rendendo quindi necessaria la tempestività nel trattamento della schizofrenia; Racamier (1980) intendeva la schizofrenia come un "insidioso e tenace tentativo di suicidio psichico" (p. 32) dovuto alla sovversione del processo secondario da parte del processo primario, dove l'Io perde il senso del reale e il suo senso di familiarità (derealizzazione).
I persecutori e 'influenzatori' operano mediante l'elettricità o la magia. In alcuni casi il dottore trafigge gli occhi del paziente con una 'voce-coltello'. Oppure i pazienti vengono tagliati a pezzi e sottoposti a scariche elettriche, oppure nella loro testa vengono installate delle macchine. Così una paziente viene informata che la sua carne avrebbe costituito delle deliziose cotolette di vitello per lupi famelici. Alcuni pazienti dichiarano che i loro intestini sono stati attorcigliati, oppure che nel loro corpo vivono elefanti o altri animali. Un paziente crede che gli esseri umani vivano nelle sue dita e che questa gente in miniatura la voglia uccidere o succhiarle il sangue. Analogamente, alcuni pazienti hanno l'impressione di essere privati della loro forza e bellezza, che viene data a qualcun altro. Spesso gli schizofrenici affermano di essere picchiati e bruciati, che la testa gli viene girata dall'altra parte, che gli vengono accorciate le gambe, e che gli strappano gli occhi (e le occhiaie vuote si possono vedere allo specchio). Il cibo scompare dal loro stomaco; i loro testicoli si gonfiano; ogni organo viene tolto, invertito, o fatto a pezzi; oppure i loro polmoni si gonfiano perché un signore grasso è stato succhiato dentro il corpo attraverso i genitali. (Ròheim, 1955, p. 90)
Il Sé psicotico è profondamento lacerato da scissioni verticali (splitting), dove parti infantili e parti adulte continuano a vivere in parallelo: lo schizofrenico vive "nel mondo della molteplicità" come "un gregge senza pastore" (Resnik, 1986), dove al suo interno coesistono una pluralità di aspetti disparati non in contatto tra loro (divisi), che gli impediscono di sperimentarsi come una persona "intera". Nello schizofrenico si assiste ad una dispersione dell'identità, una perdita del senso di coesione del Sé, in cui non di rado si accompagna una confusione riguardo l'identità sessuale (come accadde al "malato di nervi" Daniel Paul Schreber).
Disperdendo il proprio Sé all'esterno, lo schizofrenico perde la definizione tra sé e mondo, soggetto e oggetto, identità e alterità. Nella psicosi l'Io perde di vista i propri confini (Tausk, 1919), il soggetto diventa una cosa sola con l'oggetto e le differenze tra gli oggetti vengono cancellate.
Lo schizofrenico si trova perciò a vivere il mondo in modo animistico secondo un assetto panteistico, come se tutta la realtà fosse investita del proprio mondo interiore: anche il più banale oggetto di uso quotidiano può acquistare valenze magiche, minacciose, pregne di chissà quali significati nascosti. Ròheim (1955) ha osservato l'analogia tra il modo di funzionare dello schizofrenico e la concettualizzazione del mondo basata sulla magia dei cosiddetti popoli primitivi, soprattutto inerente a timori legati alla magia nera, agli stregoni, alle fatture. Anche Jung (1939) ha accostato l'esperienza della schizofrenico a quello del "grande sogno" che riceve lo stregone del villaggio il quale, invaso e sopraffatto da contenuti arcaici dell'inconscio sotto forma di demoni o spiriti, si fa testimone di importantissimi messaggi per l'intera tribù.
Nei meccanismi psicotici si assiste continuamente ad un processo massiccio di proiezione ed introiezione (per non dire di identificazione proiettiva), come quando il soggetto si lamenta che gli altri conoscono i suoi pensieri (in quanto le sue idee non sono ben chiuse nella propria testa) o quando il malato è convinto che tutto nella realtà stia parlando di lui (idee di riferimento). La nuova realtà costruita dalle bouffées deliranti sono lo specchio dell'uso massiccio del diniego megalomanico dove l'Io cerca la propria dilatazione nel suo ritiro autistico. Infatti Kohut (1971) vedeva la psicosi come la disintegrazione del Sè grandioso del quale i frammenti sconnessi vengono ristrutturati sotto forma di deliri e dove l'Io si ripiega su sé stesso narcisisticamente. Si assiste così nel malato ad una duplice difesa: da una parte il ritiro autistico per creare in modo onnipotente un proprio mondo simbolico, dall'altro la proiezione delle parti negative di Sé sull'ambiente, che diventeranno in seguito persecutorie.
I malati lamentano che tutta la gente conosce i loro pensieri, e che i loro pensieri non sono rinchiusi nella loro testa, ma sono senza confini in tutto il mondo, cosicché passano nello stesso momento per tutte le teste degli uomini. Il paziente ha perso la coscienza di essere un'entità psichica separata, un Io con confini propri. (Tausk, 1919, p. 72)

Se si dovesse riassumere lo stato interiore dello schizofrenico, si potrebbe affermare che egli sia fondamentalmente e perennemente terrorizzato: nulla risulta indifferente ad un Io che sta andando in pezzi. Lo stato patologico che lo schizofrenico presenta non è altro che l'ultimo tentativo utilizzato (per quanto distruttivo) per proteggersi dall'annientamento del proprio Sé sempre più frammentato rispetto ad una realtà divenuta oramai insostenibile. Infatti lo schizofrenico, per quanto compromesso e destrutturato, non perde mai la sensazione di esistere, per questo è così angosciato di perdere completamente e irrimediabilmente la propria mente e le sue funzioni.
In una fase avanzata della malattia pare che egli abbia perso la capacità di sentire emotivamente. Infatti, nelle sue manifestazioni affettive, lo schizofrenico può apparire come qualcuno di totalmente devitalizzato (Minkowski, 1927): ad un interlocutore egli può sembrare come un robot, con espressioni facciali e comportamentali stereotipate, ossia come se egli non fosse realmente presente nell'interazione. Ciò è dovuto al fatto che lo schizofrenico, per evitare a tutti i costi il fardello emotivo del mondo esterno così insopportabile e inconciliabile col proprio mondo interno, arriva a dissociare ogni sentimento interiore.
Eppure, all'inizio della malattia tendenze emotive opposte si alternano repentinamente: amore e odio si confondono, la furia più intensa si può alternare con una tenerezza profonda e l'altro da santo può diventare un diavolo in un attimo, da salvatore idealizzato si può trasformare in aggressore minaccioso da cui difendersi. Rosenfeld (1965) ha sottolineato infatti come nel malato lo stato confusionale associato ad una estrema angoscia siano dovuti al fatto che i moti d'amore non riescono ad essere efficacemente separati da quelli d'odio, per cui oggetti e Sé corrono costantemente il pericolo di venire distrutti da impulsi distruttivi. E se queste contraddizioni riescono a convivere sotto lo stesso tetto psichico è perché nello schizofrenico nemmeno la scissione riesce efficacemente nel suo compito di tenere separati stati emotivi opposti.
Più di ogni altro lo schizofrenico è a contatto con il mondo sotterraneo e primitivo delle pulsioni e durante la schizofrenia si assiste ad una regressione pulsionale dove l'oralità svolge un ruolo pervasivo (dalla debolezza per fumo e dolci al significato simbolico del divorare e venire divorati...). Gli stessi atti di mangiare, succhiare, bere sono frequenti nelle allucinazioni e nei deliri persecutori di stampo cannibalico: la bocca diventa per lo schizofrenico il modo in cui egli viene assoggettato da influenze esterne. Arieti (1955) ha osservato come nella fase terminale della schizofrenia il malato sembra avere ripristinato l'abitudine del lattante di mettersi in bocca qualsiasi cosa, senza badare se l'oggetto in questione possa essere commestibile o meno.
Il mondo stesso è perennemente investito da sessualità e aggressività nelle sue forme più arcaiche: temi incestuosi e omicidi tingono le relazioni erotiche. Non di rado i casi di catatonia simboleggiano la fuga dalle azioni del malato: la fissità motoria del negativismo o della flessibilità cerea evitano il senso di responsabilità rispetto all'intensa aggressività che ogni minima volontà o azione potrebbero arrecare al mondo in modo magico e onnipotente. (Arieti, 1955)
Spesso la sessualizzazione è utilizzata per cercare di ricompattare i frammenti de Sé corporeo e come tentativo per tenere uniti i pezzi sparsi del Sé nel mondo circostante. Kohut (1971) infatti faceva notare come la persona, quando avverte una crescente e pericolosa frammentazione del Sè, tenta di reagirvi con qualche frenetica attività (sessuale, lavorativa, atletica, creativa...).
Nota è l'associazione tra episodio psicotico (in stato avanzato ma non ancora preterminale) e furore creativo (per approfondimenti...) dove i confini tra malati e artisti con affezioni psichiche diventano assai fluidi: chiunque abbia lavorato a lungo con gli psicotici ha osservato un incremento di attività creative (da quelle prettamente artistiche a quelle più ordinarie o hobbistiche) che fungono per il malato da strumenti autoterapeutici.
Solitamente la moralità dello schizofrenico fa da contraltare all'intensità pulsionale primitiva di cui è succube: nello schizofrenico si assiste ad un Super-Io arcaico, crudele e punitivo che getta il soggetto in spietati sensi di colpa. Jacobson (1964) ha mostrato come nello psicotico si tenda ad avere una dissoluzione del Super-Io, che diventa un'entità non integrata nella persona, pregna di aggressività in grado di tormentare l'Io attraverso "voci della coscienza" assillanti e contraddittorie. Benedetti (1992) ha osservato come questo Super-Io persecutorio possa servire al malato per punirsi con grande sofferenza per il fatto di nutrire intensi moti d'odio e di aggressività verso il mondo, ossia scontando tale colpevolezza con l'autodistruzione.
Quando ad essere compromessa è anche l'assetto morale, allora si può assistere ad una forma di schizofrenia di stampo psicopatico (per approfondimenti...).
Negli stati più gravi, gli altri sono così pericolosi per lo schizofrenico che egli può entrarvi in contatto solo attraverso il mondo che egli ha creato: gli altri devono essere sperimentati non come persone a sé stanti, ma come quelle parti di sé a cui lo schizofrenico ha attribuito ruoli come personaggi di un mondo immaginario. E' nota la modalità incorporativa (Fenichel, 1945) dello psicotico nei confronti dell'altro: la spinta a fagocitare l'oggetto (l'intensa brama dell'altro che possa soddisfare ogni desiderio illimitatamente e immediatamente come un neonato al seno) è accompagnata contemporaneamente al terrore di venire fagocitato dall'altro. Non essendoci confini netti, la ricerca della simbiosi si contrappone al suo evitamento più assoluto: due desideri diametralmente opposti, l'avvinarsi e l'allontanarsi, sembrano manifestarsi simultaneamente, oscillando quindi tra la compresenza di oggetti onnipotenti e idealizzati con cui ottenere un'esperienza simbiotica e oggetti persecutori dai quali scappare.
Tutto ciò non fa che amplificare la schizoidia dello schizofrenico: minacciato da più parti, il suo Io non può che ripiegarsi su sé stesso, cercando rifugio in una posizione sempre più autistica (Tustin, 1972), ossia in un mondo composto sostanzialmente da fantasie e simboli. Secondo Arieti (1955) lo schizofrenico è un essere desocializzato, non solo in quanto individuo fuori la simbolica comune della società, ma come individuo che vive in un mondo simbolico non condiviso da nessun altro se non da un Sé che però è privo anche di sé stesso. Già Freud (1923) aveva sottolineato come nelle psicosi l'Io si ritragga dalla realtà, palesando l'estremo bisogno narcisistico di creare un unico senso autoreferenziale alle cose, come un feto che cerca protezione nella propria realtà uterina. Anche Binswanger (1949), osservando nelle forme allucinatorie e deliranti l'aspetto di chiusura e di resistenza ad ogni possibilità di confutazione, ne ha sottolineato l'aspetto asociale, dogmatico e intollerante rispetto a qualsiasi realtà che non sia la propria: l'allocentrismo viene sostituito da una visione del mondo totalmente egocentrica.
Gli schizofrenici avvertono acutamente che il loro amore per gli altri può portare solo a un rifiuto, a una ferita narcisistica, e quindi a un disastro per la loro autostima. Tendono così a mantenersi distanti dagli altri e a non lasciarsi coinvolgere. Oppure, se si trovano coinvolti, si ritirano immediatamente. Appaiono lontani, indipendenti e diffidenti. La loro paura di coinvolgimento viene spesso descritta come paura di perdere l'identità o i confini del sé, paura della fusione delle rappresentazioni de sé e dell'oggetto [...] inoltre gli schizofrenici sentono che il loro amore è distruttivo per l'oggetto. (Pao, 1979, p. 84)

Non sapremo mai se la schizofrenia sia l'esito di cause filogenetiche, genetiche o intrauterine, di eventi legati alla prima infanzia, alla relazione madre-bambino, al linguaggio o alla famiglia, se sia la conseguenza di uno shock sessuale o di un incidente reale. E' chiaro che si tratta di un'altra forma di essere umani. (Bollas, 2015, p. 155).
Se si dovesse riassumere l'intero pensiero di Sullivan (1962) sulla schizofrenia, si potrebbe affermare che il fondamento della psicosi consta in una profonda e primitiva mancanza di sicurezza nella vita infantile del malato. Su questa linea di pensiero, in un testo divenuto un classico, Laing (1960) sosteneva che la schizofrenia rappresenta il sintomo incarnato della follia della famiglia: l'essere pazzi è la conseguente risposta ad un ambiente di per sé pazzo. E' noto infatti come molte famiglie di schizofrenici tendano a trattare ed etichettare il paziente come il "matto" della famiglia, ossia come depositario della follia presente negli altri membri. Ad esempio Schatzman (1973) ha evidenziato gli intensi aspetti di sadismo, crudeltà e persecuzione nell'educazione del padre pedagogista di Daniel Paul Schreber, al di là delle diverse interpretazioni che gli autori psicoanalitici diedero della psicosi del paziente (a cominciare da Freud, analizzando le memorie di questo "malato di nervi"). In altri termini, la malattia schizofrenica sarebbe il frutto della creazione di una famiglia che combatte nell'individuo designato le strane tendenze e la medesima follia che ella riconosce in se stessa: "l'irrazionalità dello schizofrenico trova la propria razionalità nel contesto sociale della sua famiglia originaria" (Schatzman, 1973, p. 152).
In genere la letteratura psicoanalitica ha sottolineato l'importanza delle primissime esperienze di vita del bambino nel predisporre alla futura patologia schizofrenica. In particolare è perdurato il concetto di "madre schizofrenogenica" (Fromm Reichmann, 1950), ossia un genitore che cerca parassiticamente un rapporto simbiotico col figlio e al medesimo tempo lo rifiuta e lo respinge. Bateson et al. (1956) descrissero questo tipo di relazione morbosa attraverso il processo del "doppio legame": l'imposizione contemporanea di due ingiunzioni inconciliabili, in modo che sia impossibile obbedire ad una senza per forza di cose disobbedire ad un'altra.
La paradossalità di tale comunicazione relazionale crea infatti nel soggetto una sorta di blocco del pensiero, dove il bambino viene continuamente squalificato nella percezione che ha della realtà, ed è costretto a rinunciarvi pur di non perdere l'amore del genitore. Il messaggio che il genitore trasmette al figlio è che una simbiosi interrotta (ovvero una separazione) comporterà il ritiro totale dell'amore verso figlio o il fatto che il genitore impazzirà di dolore. Secondo Searles (1965) la malattia schizofrenica rappresenta infatti "il sacrificio da parte del figlio della sua stessa individualità per il benessere della madre" (p. 209): egli si fa inconsciamente carico della follia del genitore per poterlo guarire, in una relazione dove l'individuazione è associata a pericolo, perdita, morte.
Secondo l'autore infatti, l'amore della madre, benché autenticamente presente, è caratterizzato da una forma primitiva (orale-incorporativa) di relazione, dove i sentimenti d'amore, avvertiti da lei come pericolosi, vengono alternati da moti di collera difensivi, cosicché il figlio si sente appassionatamente e visceralmente amato per poi ritrovarsi improvvisamente odiato e rifiutato. Questa modalità interpersonale stimola lo sviluppo di continui conflitti emotivi nel bambino, attivando ed isolando vari aspetti della sua personalità in contrasto tra loro, secondo quindi una modalità che tende a "farlo diventare pazzo" (ibid., p. 245), schizofrenico per l'appunto. Molti schizofrenici raccontano infatti di avere avuto non una madre, ma molte madri
Quando questi bambini percepivano la collera e l'ostilità di un genitore, come accadeva in numerose occasioni, immediatamente il genitore negava di essere in collera e insisteva perché anche il figlio lo negasse; di conseguenza il bambino si trovava di fronte al dilemma di credere al genitore oppure ai propri sensi. Se credeva ai propri sensi, riusciva a mantenere una solida presa sulla realtà; se credeva al genitore, conservava il rapporto di cui aveva bisogno, ma distorceva la propria percezione della realtà. La ripetuta negazione delle sue percezioni da parte del genitore finiva per impedire al bambino di giungere a un adeguato esame di realtà. (Johnson et al. in Searles, 1965, p. 249)
Secondo Arieti (1955) la schizofrenia "è una reazione specifica ad un grave stato di ansietà, che ha avuto origine nell'infanzia ed è stato riattivato più tardi nel corso della vita da fattori psicologici" (p. 353). Secondo l'autore, il meccanismo così pervasivo della proiezione nella schizofrenia (soprattutto paranoidea) è anche finalizzata a restituire ciò che il malato non accetta più come parte di sé in termini di auto-condanna a chi in realtà ha contribuito a costruire quella parte di sé. In altri termini, il malato rifiuta di continuare a provare odio verso sé stesso, ritornando così a ripetere l'antica esperienza di essere odiato da parte del proprio persecutore originario, il genitore (che costringe a vedere il mondo in conformità ai soli propri desideri), ora spostato simbolicamente su altri. Questo perché "per il malato sarà più facile sentire e manifestare ostilità verso questi persecutori immaginari, o vendicarsi su di loro, che nutrire sentimenti ostili o vendicativi verso i propri genitori" (p. 280).
Secondo Ròheim (1955) la sintomatologia schizofrenica è un modo per compensare la separazione dall'unità diadica con la madre: le stesse voci o intrusioni del materiale primario non rappresenterebbero che l'identificazione con la madre stessa che si rivolge al figlio. Zapparoli (1987) ha ipotizzato che con la pubertà, ossia durante la maturazione sessuale (fase genitale), la sessualità, ad un livello psichico, invece che diventare una forza che spinge il ragazzo fuori dalla famiglia, essa venga utilizzata per rafforzare il legame fusionale con la madre (sessualizzazione della simbiosi). E così: "nella relazione fusionale si stabilisce un particolare rapporto 'segreto' tra madre e figlio, che fa sentire esclusi, incapaci e impotenti coloro che tentano di far venire alla luce questo loro segreto" (ibid., p. 75). Non di rado le famiglie degli schizofrenici tendono a comunicare al malato che i suoi bisogni, di qualsiasi tipo, possano o debbano essere appagati all'interno dell'ambiente famigliare stesso.
Racamier (1980) ho sottolineato la connotazione di "feticcio vivente" che assume il bambino per una madre che in generale non gli consente di nascere psicologicamente: al bambino non è permesso di possedere un proprio Io e di viversi come un'entità umana separata dalla madre. Racamier (1992) infatti ha evidenziato il forte carattere "incestuale" della relazione del bambino con la madre, improntata non necessariamente su un incesto agito (concreto), ma su un legame basato su seduttività mista a rifiuto che mira a fare del bambino "una cosa sua, un suo strumento, una sua proprietà", come se di fatto egli "non fosse mai nato" (p. 143). In altri termini, ciò che secondo l'autore viene rifiutato da parte della madre è che il proprio figlio possa godere di vita propria e di autonomia. Pankov (1969) ha osservato come in queste famiglie spesso il padre, pur ancora in vita, "è presente sotto la modalità dell'assenza" (p. 148), nel senso che di fatto egli non esercita il ruolo paterno nei confronti del bambino: "il padre, che la madre ha divorato e distrutto, deve dunque essere ritrovato in e attraverso il corpo della madre" (p. 150).
Il prodotto di tale relazione è un attaccamento disorganizzato (Bowlby, 1969-1980) dovuto ad una relazione altamente mutevole e totalmente imprevedibile, che non permette al bambino di interiorizzare una relazione sicura e costante con la madre, restando affamato e imprigionato in quella medesima relazione simbiotica che egli non è riuscito a vivere con una certa serenità necessaria alla crescita (Mahler, 1968). Sullivan (1962) infatti ha descritto il ruolo di esperienze esageratamente angoscianti nel bambino (il "non-me") che non possono essere integrate dalla coscienza (e pertanto vengono difensivamente dissociate), contribuendo a frammentare il sistema Sé dell'adulto. Mentre nella concettualizzazione schizoparanoide della Klein (1946) la frustrazione orale del bambino innesca moti d'odio e d'aggressività che, venendo proiettati sulla madre, la trasforma in minaccia distruttiva fino a venire introiettata una volta adulto come persecutore internalizzato.
Tuttavia, vi possono essere manifestazioni morbose di tipo schizofrenico anche nei soggetti che, pur presentando traumi cumulativi identificabili, nella loro storia infantile non hanno vissuto un ambiente famigliare così patologico da giustificare la malattia. Così come è possibile rinvenire certe dinamiche morbose proprie della psicosi anche nelle storie infantili di adulti che sono diventati nevrotici e non schizofrenici.
Infatti, come per altri quadri psicopatologici, anche la componente genetica-ereditaria svolge nella schizofrenia un aspetto importante, ma che da sola, come per il solo ruolo dell'ambiente, non spiegano direttamente la causa della schizofrenia. E' vero che da un punto di vista biologico si sono evidenziate alterazioni somatiche: ipotensione, tendenze allo vasocostrizione, disturbi endocrini, cambiamenti metabolici e alterazioni cerebrali visibili via TC e PET (come un'atrofia periventricolare, difetti neurotrasmettitoriali e ipofunzionalità delle aree corticali). Tuttavia non si può sapere per certo se tali fenomeni rappresentino la causa o invece, come è più probabile, se essi derivino dall'effetto prolungato dell'esperienza sconvolgente di isolamento e di alienazione che vive lo schizofrenico. In questo Jung (1908) fu il primo psichiatra della storia che ha ipotizzato come potessero essere cause psichiche ad alterare il sistema nervoso, contrariamente al resto della comunità psichiatrica di quei tempi che considerava la schizofrenia come un disturbo organico,

Come accade per molte realtà fenomeniche riguardo l'essere umano, la gravità della psicopatologia solitamente rivela con maggiore nitidezza e intensità ciò che in realtà appartiene anche all'uomo "comune". Mi riferisco in particolare a ciò che la psicosi mette in luce nella maniera più immediata e lancinante: l'ambigua e fondamentale nostalgia uterina (protratta con la simbiosi materna) che accompagna l'esperienza umana in ogni sua manifestazione (per approfondimenti...). Racamier (1992) infatti sostiene che "niente come la psicosi vale a illuminare, sia pure controluce, le fasi più segrete della vita psichica" (p. 24), in particolare modo ciò che l'autore definisce il "lutto delle origini". Esso, non identificabile con la depressione, rappresenta quel "processo psichico fondamentale per il quale l'Io, fin dalla prima infanzia, prima ancora di emergere e fino alla morte, rinuncia al possesso totale dell'oggetto, compie il lutto di un'unione narcisistica assoluta" (ibid., p. 39), in una sorta di "attraversamento, che non smette mai di compiersi o di approfondirsi lungo le diverse età della vita." (p. 40). E nell'organizzazione psicotica, tale processo è arduo più che mai: d'altronde proprio Freud (1923) parlava di odio verso la realtà come caratteristica primaria dello psicotico. Mentre ancora prima di Freud, fu la Spielrein (1912) ad accorgersi di come nella ricerca della distruzione e nell'atteggiamento mortifero dell'autolesionismo (tipici della psicosi) si celino il desiderio di dissolversi nel corpo della madre, l'aspirazione dell'essere di tornare indifferenziato in questo inconscio originario (la madre).
In tale prospettiva, la patologia psicotica rappresenta forse la più chiara manifestazione di tale contrapposizione esistenziale: da un lato la smania di crescere, rendersi autonomi, elaborare il lutto, ossia nascere psicologicamente, dall'altro la permanenza nell'indifferenziato, nell'onnipotenza autistica, nella simbiosi col primo oggetto d'amore, la madre. Non a caso Benedetti (1992) descriveva il mondo dello schizofrenico come pieno di paradossi (d'altronde, come ricorda Freud, nell'inconscio gli opposti coesistono): se il malato cerca di separarsi dalla propria madre che vive simbioticamente dentro di sé, egli rischia di "morire di sete, perché l'acqua è un elemento materno" (p. 104). Anche da un punto di vista clinico, si può vedere questa duplice oscillazione dello schizofrenico in base a come si relazione col mondo (simbolicamente, la madre): da una parte si separa autisticamente da esso (divenendo egli stesso il grande Onnipotente che non può venire scalfito da nulla), dall'altro egli vi si fonde continuamente attraverso i diversi scambi simbolici con esso basati su proiezione e introiezione.
Mi hanno chiamato folle; ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell’intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell’intelletto in generale. (E. A. Poe, Eleonora)
Per quanto molto spesso sia essenziale la via farmacologica in questo tipo di psicopatologia (che di fatto è la più grave nel panorama umano delle condizioni morbose), è abbastanza sconfortante osservare come molti pazienti psicotici, al momento delle dimissioni in seguito ad un periodo di ricovero, si trovino spesso a dovere assumere per il resto della loro vita un cocktail di psicofarmaci (la "terapia di mantenimento") che il più delle volte li intorpidisce a tal punto da appiattirne l'intera personalità. Se è vero che in passato il cosiddetto "pazzo" era semplicemente rinchiuso a vita nei manicomi (per approfondimenti...), oggi non di rado si assiste ad una "incarcerazione psicotropa" (Bollas, 2015), dove pur di sbarazzarsi in fretta e furia del sintomo "troppo spesso non si tiene conto che sintomo e persona sono, per molti aspetti, tutt'uno, e che la medicalizzazione minaccia di eliminare la dimensione umana" (p. XVII). E' come se la via farmacologica rappresentasse il compromesso optato dalla società tra la necessità di intervento del malato in uno stato di bisogno acuto e i mezzi sociosanitari disponibili delle istituzioni, quest'ultime sempre più in affanno rispetto all'enorme bacino di pazienti che richiedono aiuto.
Ovviamente non si tratta di non prescrivere farmaci o ricoveri quando strettamente necessari, ma di accompagnare questi interventi sempre da un'adeguata "psicoterapia intensiva orientata psicoanaliticamente" (Fromm-Reichmann, 1950), la sola in grado di modificare la struttura del paziente. Infatti in letteratura (ahimè, oramai, quella più datata), la maggior parte dei clinici psicodinamici che si è occupata intensivamente di pazienti schizofrenici ha sottolineato la necessità di una psicoterapia intensiva, prolungata e sinergica all'interno di un contesto che possa offrire al paziente una relazione di aiuto significativa e costante.
Benedetti (1988), in una metanalisi di studi sul trattamento della schizofrenia (comprendente circa 500 casi trattati da lui e collaboratori) ha infatti rilevato come solo un quinto dei pazienti schizofrenici rimase inscalfibile da quell'esperienza profonda e trasmutativa propria della relazione terapeutica che forse è la sola in grado di reinserire l'enigma della schizofrenia nel registro dell'umano. Dipende infatti dalla capacità del terapeuta di "ritrovare se stesso dentro il delirio del paziente, di peregrinare nei propri sogni per le contrade della follia, di vestire gli abiti del paziente" (ibid., p. 50), la possibilità di ristabilire un contatto umano terapeutico con chi si sente appartenente ormai ad un altro mondo. Interventi che, a fronte degli studi sulle famiglie schizofrenogeniche, dovrebbero trovare necessariamente la collaborazione dell'ambiente attorno al malato, come già aveva notato Federn (1956) tanti anni fa.
All'irrazionale psicotica non viene contrapposta la razionalità, ma la creatività terapeutica. Alla fine di questo processo di graduale trasformazione si arriva alla creazione di un nuovo rapporto là dove rapporto non esisteva, e quindi alla creazione di un nuovo e originale mondo psichico che, creato e alimentato nella relazione duale paziente/terapeuta, potrà in seguito svilupparsi ed evolversi in modo autonomo nel tempo e nello spazio storico e reale. [...] Così, l'intera psicologia o psicoterapia delle malattie nervose gravi, delle psicosi è un unico sforzo di proiettare il comprensibile nell'incomprensibile, comprendendolo e attraendo così il paziente nell'orbita interumana. (Benedetti, 1988, p. 35)
Da un punto di visto sociologico, lo schizofrenico rappresenta una delle forme più radicale di ousider, in quanto egli, vivendo nello stato oniròide del proprio mondo fantastico, si è liberato del mondo reale e delle sue difficoltà, delle sue fatiche, delle sue responsabilità. Egli è cioè ritornato (seppur temporaneamente e con intensa ambivalenza) a quel mondo magico e relativamente idilliaco della vita infantile dove egli poteva godere di quasi illimitati privilegi e libertà. In senso lato, è come se la psicosi minacciasse le precarie fondamenta su cui si erige l'intera società col suo bisogno di ordine e razionalità che la possano proteggere da un'anarchia disgregante, da forze primordiali e oscure che in un attimo potrebbero spazzare via tutte le norme che la regolano e la conservano. Ma la rottura messa in atto inconsciamente dai cosiddetti "pazzi" non fa che smascherare una pazzia ancora più grande intrinseca nella società, ossia la normopatia (per approfondimenti...). Non a caso Benedetti (1992) scriveva che non di rado lo psicoterapeuta avverte che "nel delirio del suo paziente ci può essere più vita che nella sanità sociale di molte persone" (p. 274). Il problema centrale è che una cultura inflazionata sulla "scienza", la produttività e l'efficienza come la nostra che non lascia spazio all'esistenza dell'irrazionale e della follia intrinseca nell'uomo (per approfondimenti...), non può che sclerotizzarsi e, come è risaputo, subire poi con violenza e sgomento la stessa irrazionalità e la stessa follia che essa denega.
Il tal senso Szaz (1961) ha denunciato il fatto che finché si consideri la salute mentale solo come un orientamento e un buon adattamento alla società d'appartenenza secondo certi ideali e valori normativi di riferimento, allora sarà la società stessa, nei suoi tentativi di donare salute, a creare continuamente follia. E allora le istituzioni, capeggiate dalla psichiatria, rischiano di diventare speculari alle stesse famiglie schizofrenogeniche che a suo tempo non hanno saputo accogliere, gestire e integrare la follia del bambino, relegandola sempre più in profondità fino a divenire inevitabilmente un morbo che può trovare spazio solo nella persecuzione dell'allucinazione, nella distanza del delirio, nell'isolamento dell'angoscia. Questo perché la società è terrorizzati dalla follia, dal caos dell'irrazionale, dall'ignoto che alberga l'inconscio, dimentichi che questi albergano anche i loro luoghi psichici e che spesso, ciò che divide il "sano" dal "malato" è solo una scrivania, quello dello psichiatra, che delimita artificiosamente uno spazio comune. Mentre la situazione che permane è quella di una scissione tra normale e patologico che fa sentire il malato ancora più matto e diverso, e quindi sempre più solo e cronicamente ammorbato, incapace di accogliere la propria follia in modo trasformativo in questo contesto iatrogeno di "normalizzazione".
I pazienti schizofrenici con i loro simboli e i loro deliri dicono verità gravi, le quali valgono nella nostra società anche al di fuori del caso psicopatologico: così, la verità che l'adattamento è spesso solo la collaborazione in un inganno reciproco; oppure la verità della menzogna implicita nel voler chiamare amore il semplice possesso d'un altro; o ancora, la verità che personalità 'indipendenti' nella nostra società sono quelle che si sono meglio adattate ai programmi loro impartiti per motivi di egoismo, ambizione, ecc., mentre gli schizofrenici, esseri dipendenti, sono proprio quelle non-persone che, attraverso il tragico sabotaggio della malattia, si sono rifiutate ad essi. (Benedetti, 1988, p. 74)
Eppure Jung ha più volte sottolineato come la psicosi possa rappresentare un processo inconscio compensatorio per riorganizzare un Sé sconvolto dall'adattamento con la realtà attraverso il ricorso del mondo arcaico dei simboli e delle immagini proprie dell'inconscio, intento a recuperare i significati perduti. In tale prospettiva, la regressione tipica della psicosi non riconduce l'individuo solo ai livelli infantili di sviluppo, ma anche nelle zone più arcaiche e vitali dell'inconscio, così come, riattivando il desiderio simbiotico per la madre e l'incesto, essa è in grado di permettere una rigenerazione, una rinascita attraverso la madre simbolica. Perry (1974) ha infatti evidenziato il parallelismo tra molti riti iniziatici di rinascita presso i primitivi (Eliade, 1958) e il processo schizofrenico: prima della rinascita sono tipici i motivi di smembramento, di morte, di intensa mortificazione. Anche l'esperienza di molti mistici della storia cristiana si possono reperire tipiche manifestazioni che oggi molti psichiatri considererebbero psicotiche (per approfondimenti...): "invece di chiederci cosa c'è di patologico nel misticismo, chiediamoci piuttosto cosa c'è di mistico nell'intento della psicosi" (Perry, 1974, p. 152), e "ciò che per lo schizofrenico costituisce occasione di panico, di fronte a un 'viaggio di morte' che egli non comprende, è per il mistico che ha conosciuto la morte, un evento di benvenuto" (ibid., p. 157).
Similmente Benedetti (1992) ha parlato di "psicopatologia progressiva" alludendo al fatto che una psicopatologia inizialmente regressiva e disfunzionale, se accolta adeguatamente da un terapeuta capace di vederne il suo valore trasformativo ed integrativo, sfocia in una dimensione progressiva in grado di condurre la persona oltre il suo stato precedente ampliando e arricchendo l'intero Sé. Il grande psichiatra Arieti (1955) ha osservato come la psicosi, da una parte ha maldestramente lo scopo di ridurre l'ansietà della persona, dall'altra "permette all'originalità dell'individuo di emergere" (p. 294): in senso quasi paradossale "per ritrovare se stesso come individuo egli deve [prima perdersi, ossia] diventare psicotico" (ibid.).
In altri termini, la psicosi appare come una modalità facente parte dell'umana esperienza per riorganizzare profondamente la propria esistenza. Tutto sta nel trovare l'aiuto necessario per riuscire a reintegrare i contenuti inconsci che emergono con violenza nella nuova potenziale strutturazione del Sé, affinché la persona non si smarrisca totalmente nel caos prolifico della propria follia (per approfondimenti...). La psicosi mette in luce la necessità di far morire un intero pseudo Sé per farne nascere uno nuovo, a costo di compiere un lungo, difficilissimo lutto della perdita dell'oggetto originario: come ogni viaggio iniziatico, esso non può essere compiuto senza una brava guida.
In breve, si possono compendiare i contenuti come temi di tipo mitologico che si orientano secondo un distinto piano di base, a dispetto della superficiale casualità dell'apparire del flusso dei contenuti simbolici. C'è una fase iniziale in cui compaiono temi di morte e di dissoluzione di vecchi aspetti. Il processo si spinge verso uno stato di disordine in cui entrano in gioco elementi opposti di tutti i generi: luce e tenebre, bene e male, bello e brutto, ordine e caos, idee politiche rivoluzionarie e conservatrici, pace e guerra, qualità maschili e femminili ed una folta schiera di altri principi contrastanti. L'individuo esperisce questi opposti scindendosi, scontrandosi con l'uno e con l'altro, capovolgendo le loro posizioni relative e, infine, unendoli nella sintesi. Segue, quindi, una fase di creazione e di nascita di nuovi aspetti (Perry, 1974, p. 212)

Arieti S. (1955). Interpretazione della schizofrenia. Feltrinelli, Milano, 1963.
Bateson et al. (1956). Verso una teoria della schizofrenia. In Sluzki C., Ramson D., Il doppio legame. Astrolabio, Roma, 1979.
Benedetti G. (1988). La schizofrenia. Guerini e associati, Napoli.
Benedetti G. (1992). La psicoterapia come sfida esistenziale. Raffaello Cortina, Milano, 1997.
Binswanger L. (1949). Essere nel mondo. Astrolabio, Roma, 1973.
Bion W. (1967). Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Armando, Roma, 1979.
Blueler E. (1911). Trattato di psichiatria. Feltrinelli, Milano, 1967.
Bollas C. (2015). Se il sole esplode, Raffaello Cortina, Milano, 2016.
Bowlby J. (1969-1980). Attaccamento e perdita. Bollati Boringhieri, Torino, 1972-1982.
Eliade M (1958). La nascita mistica. Morcelliana, Brescia, 1976.
Federn P. (1956). Psicosi e psicologia dell'Io. Bollati Boringhieri, Torino, 1976.
Fenichel O. (1945). Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi. Astrolabio, Roma, 1951.
Freud S. (1911). Caso clinico del presidente Schreber. OFS vol. 6. Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1923). Nevrosi e psicosi. OFS vol. 9. Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Fromm-Reichmann F. (1950). Principi di psicoterapia. Feltrinelli, Milano, 1962.
Hartmann H. (1964). Saggi sulla psicologia dell'Io Boringhieri, Torino, 1976.
Jacobson E. (1964). Il Sé e il mondo oggettuale. Martinelli Ed., Firenze, 1974.
Jung C.G. (1904). Importanza dell'inconscio in psicopatologia. Opere, Vol. 3, Bollati Boringhieri, 1971.
Jung C.G. (1908). Il contenuto della psicosi. Opere, Vol. 3, Bollati Boringhieri, 1971.
Jung C.G. (1939). Psicogenesi della schizofrenia. Opere, Vol. 3, Bollati Boringhieri, 1971.
Jung C.G. (1958). La schizofrenia. Opere, Vol. 3, Bollati Boringhieri, 1971.
Klein M (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi in Scritti (1921 - 1958). Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
Kohut H. (1971), Narcisismo e analisi del Sè, Bollati Boringhieri, Torino, 1976.
Laing R. (1959). L'io diviso. Studio di psichiatria esistenziale. Einaudi, Torino, 1972.
Mahler M. (1968). Le psicosi infantili. Bollati Boringhieri, Torino, 1972.
Minkowski H. (1927). La schizofrenia. Bertani, Verona 1980.
Pankov G. (1969). L'uomo e la sua psicosi. Feltrinelli, Milano, 1977.
Pao P. (1979). Disturbi schizofrenici. Teoria e trattamento da un punto di vista psicodinamico. Raffaello cortina, Milano, 1984.
Perry J.W. (1974). La dimensione nascosta della follia. Liguori Ed, Napoli, 1980.
Racamier P. (1980). Gli schizofrenici. Raffaelo Cortina, Milano, 1983.
Racamier P. (1992). Il genio delle origini. Raffaelo Cortina, Milano, 1993.
Resnik S. (1986). L'esperienza psicotica. Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
Ròheim G. (1955). Magia e schizofrenia. Ghibli Ed., Milano, 2015.
Rosenfeld H. (1965). Stati psicotici. Un approccio psicoanalitico. Armando, Roma, 1973.
Schatzman M. (1973). La famiglia che uccide. Feltrinelli, Milano, 1973
Searles H. (1965). Scritti sulla schizofrenia. Bollati Boringhieri, Torino, 1974.
Spielrein S. (1912). La distruzione come causa della nascita. In Comprensione della schizofrenia. Liguori Ed. Napoli, 1986.
Sullivan H.S. (1962). Scritti sulla schizofrenia. Feltrinelli, Milano, 1994.
Szaz T. (1961). Il mito della malattia mentale. Il Saggiatore, Milano, 1974.
Tausk V. (1919). Scritti psicoanalitici. Astrolabio, Roma, 1979.
Tustin F. (1972). Autismo e psicosi infantile. Armando, Roma, 1977.
Zapparoli G. (1987). La psicosi e il segreto. Boringhieri, Torino.
π - Il teorema del delirio, di D. Aronofsky (1998)
A beautiful mind, di R. Howard (2001)
Antichrist, di L. von Trier (2009)
Benny & Joon, di S. Chechik (1993)
Betty Blue, di J.J. Beineix (1986)
Brama di vivere, di V. Minnelli (1956)
Che fine ha fatto Baby Jane?, di R. Aldrich (1962)
Come in uno specchio, di I. Bergman (1961)
Diario di una schizofrenica, di N. Risi (1968)
Donnie Darko, di R. Kelly (2001)
Erasehead - La mente che cancella, di D. Lynch (1977)
Fight club, di D. Fincher (1999)
Il gabinetto del dott. Caligari, di R. Wiene (1920)
Joker, di T. Philips (2019)
K-Pax - Da un altro mondo, di I. Softley (2001)
L'inquilino del terzo piano, di R. Polanski (1976)
Macbeth, di O. Wells (1948)
Mulholland Drive, di D. Lynch (2001)
Number 23, di J. Schumacher (2007)
Prendimi l'anima, di R. Faenza (2002)
Psycho, di A. Hitchcock (1960)
Qualcuno volò sul nido del cuculo, di M. Forman (1975)
Quello che tu non vedi, di T. Freudenthal (2020)
Ragazze interrotte, di J. Mangold (1999)
Repulsione, di R. Polanski (1965)
Shine, di S. Hicks (1996)
Shining, di S. Kubrick (1980)
Shutter Island, di M. Scorsese (2010)
Spider, di D. Cronenberg (2002)
Strade perdute, di D. Lynch (1997)
Taxi driver, di M. Scorsese (1976)
Take Shelter, di J. Nichols (2011)
Il Blog, che riceve migliaia di visualizzazioni giornaliere, contiene articoli coperti da diritti d'autore, ognuno dei quali proviene da mesi di scrupolose ed estese ricerche sul tema. Ciononostante si è scelto di divulgare tali studi in maniera completamente gratuita, senza la necessitò di affiliazioni obbligatorie ad istituzioni o riviste ed escludendo qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria. Si prega pertanto di fare buon uso di tale materiale, con l'augurio che tali contenuti possano rappresentare una fonte di stimolo per chiunque abbia interesse ad esplorare tutto ciò che riguarda quel curioso e misterioso fenomeno che è l'essere umano.
Commenti