28 nov 2025Tempo di lettura: 23 min


2 nov 2025Tempo di lettura: 34 min


13 lug 2025Tempo di lettura: 5 min
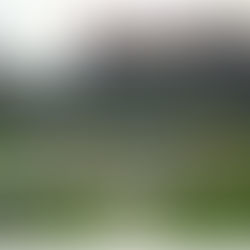

4 apr 2025Tempo di lettura: 6 min


16 mar 2025Tempo di lettura: 29 min




Versione PDF stampabile:

Relazione tenuta per il XXI Convegno Congiunto Opifer - Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro - AAPDPP (American Academy of Psychodynamic Psychiatry and Psychoanalysis).
Riassunto
Il presente lavoro intende valorizzare l'importanza cruciale del perenne scambio inconscio che permea la coppia analitica, in un contesto odierno dove nelle Scuole di specializzazione teoria e tecnica o si fanno sempre più marginali lasciando il posto ad una sorta di improvvisazione basata sull’esclusivo sentire soggettivo (in un contesto di pericolose ingenuità e ignoranza), oppure esse diventano le anguste sponde di un letto di Procuste in cui infilare qualsiasi paziente (perdendo quindi l'unicità e la vitalità di ogni relazione analitica). Perciò l'autore suggerisce di recuperare il prezioso lavoro condotto da Robert Langs, in particolare modo lo strumento della validazione degli interventi del terapeuta, che risulta fondamentale non solo in supervisione nei momenti di stallo o di criticità, ma anche per controllare l'andamento della terapia durante la pratica clinica quotidiana. Infine, a supporto dell'importanza di tali studi, vengono riportate brevemente questioni teoriche sollevate da Morris Eagle concernenti il ruolo pervasivo dell’insight anche in quelle psicoterapie che enfatizzano l'esclusività della “relazione” come fonte del processo mutativo nel paziente.
Dalla mia formazione psicoanalitica ricordo ancora con una certa lucidità le esperienze imbarazzanti con i cosiddetti supervisori clinici che mi erano stati assegnati in qualità di allievo: uno che aveva completamente perso la dimensione simbolica della genitorialità analitica, trattando concretamente i pazienti come fossero figli da amare; uno fissato con la psicoeducazione per cui la terapia finiva per assomigliare ad una lezione didattica puramente intellettuale; uno che probabilmente ignorava completamente i concetti fondamentali della terapia psicoanalitica, inneggiando a lasciarsi guidare interamente dalla “pancia” nella conduzione analitica; un altro che suggeriva ogni intervento terapeutico conosciuto purché non fosse analitico, creando un contesto clinico sostanzialmente basato sull’agito. Insomma, era abbastanza evidente che questi colleghi esperti non facevano che adoperare in supervisione lo stesso modello terapeutico che ahimé erano soliti impiegare anche nella loro pratica clinica quotidiana. D’altronde, girando un po’ per Scuole ed Istituti, mi è sembrato di notare come la formazione tenda a seguire solitamente due tendenze opposte: l’una, con la mania del controllo e della categorizzazione, improntata ossessivamente ad un uso smodato della teoria che nella pratica clinica poi fatica a lasciare spazio anche al sentire, alla spontaneità e alla rêverie; l’altra che quasi trascura completamente la teoria esasperando inverosimilmente i costrutti di relazione, del qui e ora, della componente “viscerale” della dimensione analitica. A ben vedere queste sembrano essere due facce d'una stessa medaglia che in fin dei conti non tiene conto dell’effettiva realtà inconscia tra paziente e analista che si instaura ogni volta in maniera originale in stanza d’analisi.
Questo aspetto è stato brillantemente studiato a più riprese da Robert Langs, evidenziando come l’inconscio del paziente sia in grado di percepire adeguatamente la correttezza o meno degli interventi del terapeuta comunicandogli in “codice” tale percezione (ossia attraverso immagini trasformate in derivati sottoposti a mascheramento e spostamento), al di là di quanto il paziente possa affermare o meno a livello conscio. Ad esempio, interventi corretti da parte del terapeuta aprono la pista a nuove associazioni o ad espansioni tematiche più profonde, mentre infrazioni o errori possono venire comunicati attraverso materiale non convalidante come temi che fanno riferimento a inazione, assenza, incapacità, invisibilità. Già Searles (1975) aveva descritto come il paziente sia in grado di individuare inconsciamente gli errori del terapeuta e di fornirgli una via per correggerli, considerando la psicopatologia in toto come un tentativo terapeutico del bambino nei confronti delle lacune educative del genitore: “il paziente cerca di aiutare l'analista a condividere quelle modalità di rapporto interpersonale che per il paziente sono relativamente libere dall'angoscia, mentre per l'analista sono cariche d'angoscia. (...) Assumendo la parte disturbata dell’analista dentro di sé e trattando ‘l’analista disturbato’ all'interno di sé stesso, alla fine può nascere dal paziente un analista più sano” (p. 314-315).
In una eccezionale ricerca ormai divenuta un classico, Robert Langs (1985) intervistò approfonditamente venti ex pazienti sulla qualità percepita delle proprie esperienze terapeutiche con diversi terapeuti di vari orientamenti (ben settantatre in totale): il fatto sorprendente fu che, nonostante le più disparate infrazioni e violazioni del setting (alcune anche gravi), solo un paziente criticò negativamente la propria esperienza. Tutti gli altri intervistati dichiararono, a livello conscio, generali soddisfazione e gratitudine affermando di sentirsi sinceramente meglio e riportando un discreto sollievo dai sintomi iniziali, senza mai descrivere i comportamenti dei propri ex terapeuti come irresponsabili e nocivi. Eppure, analizzando i sogni ed i derivati mascherati e spostati delle loro libere associazioni, Langs scoprì tutt’altro scenario: a livello inconscio, questi ex pazienti avevano avuto l’esatta percezione di come era andata la propria terapia, rivelando un senso generale di sfiducia, abbandono, inutilità e pericolo. Langs ipotizzó che ciò che aveva alleviato i sintomi degli ex pazienti erano stati metodi di “cura” basati fondamentalmente sulla follia del terapeuta, quali l’approvazione indiretta dei comportamenti patologici del paziente, punizioni che leniscono il senso di colpa, gratificazioni eccessive, compiti atti a spostare il problema centrale del paziente… che di fatto venivano intesi dal sistema conscio e da quello inconscio in modo opposto. Già Glover (1955) aveva evidenziato come le interpretazioni inesatte dell’analista (quando fortemente investite dall’autorità transferale divenendo quindi abbastanza persuasive) potevano ridurre o addirittura temporaneamente risolvere la sintomatologia del paziente attraverso vari sistemi di spostamento egosintonici dell’angoscia. Invece che scoprire le zone in ombra della rimozione per arrivare ai nuclei profondi dell’inconscio dove risiede la verità psicopatologica del paziente, secondo Glover il terapeuta rimanendo in superficie rafforza l’atteggiamento fobico del paziente rispetto alla propria follia attraverso una “forma di suggestione che potrebbe considerarsi come un tipo di omeopatia” (p. 419).
Riuscire a comprendere la comunicazione inconscia attraverso la validazione degli interventi permetterebbe quindi al terapeuta di possedere una solida bussola per orientarsi nella pratica clinica ed arrivare così ai nuclei patologici profondi del paziente. Secondo Langs (1988) infatti una terapia solamente “orientata alla realtà”, ossia un lavoro focalizzato principalmente sui contenuti manifesti e sugli aspetti più superficiali della vita psichica, comunica al sistema inconscio profondo del paziente che anche il terapeuta ha agito difensivamente rispetto ai conflitti nodali più profondi della propria vita inconscia, non consentendo di conseguenza al paziente di padroneggiare meglio la propria follia. Similmente scrive McWilliams (2021): “è probabile che terapeuti che offrono solo rassicurazioni, cornici concettuali, obiettivi comportamentali e altre distrazioni non siano testimoni di un processo di guarigione profonda” (p. 79)
In generale ho potuto rilevare una sconcertante tendenza, da parte dei terapeuti che figurano in questa ricerca, a minimizzare, negare e giustificare i chiari segni di follia dei pazienti; questi sforzi, tuttavia, venivano compiuti principalmente in nome della ricerca delle radici e delle cause della follia. Nella gran parte dei casi né il paziente né il terapeuta erano coscienti del loro ricorso al diniego; pertanto gli sforzi volti a individuare la follia diventavano in realtà dei tentativi di cancellarne l'esistenza, in maniera esplicita nel paziente, implicita nel terapeuta. Anche se in questo modo si è ottenuto qualche sollievo, la mancanza più grave si è rivelata essere l'incapacità di affrontare sul serio i profondi disturbi nella sfera emotiva dei pazienti e di aiutarli a raggiungerne la padronanza. (Langs, 1985, p. 80)
In quest’ottica, è chiaro che non mi trovo d’accordo con la prospettiva contemporanea che tende ad intendere la psicoterapia essenzialmente come un’ermeneutica costruita tra paziente e analista purché sia fondata su narrazioni condivise dotate di senso. Come scrive Eagle (2021) “da ciò non consegue che narrazioni coerenti e plausibili diverse abbiano lo stesso status esplicativo o valore di verità. L’adeguatezza esplicativa o la veridicità di una narrazione possono avere solo una debole associazione con il suo impatto o la sua persuasività” (p. 267). Famosa infatti è l’asserzione di Freud (1915-1917) che solo le interpretazioni “che concordano con la realtà” del paziente (p. 601) sono in grado di portare ad una reale efficacia terapeutica. Mentre Codignola (1977) scriveva che nel momento in cui l'analista interpreta, per forza di cose egli “assume un punto vero come segnale di riferimento cognitivo” (p. 102) rispetto ad una “falsità parziale di ciò che viene interpretato (...) frutto di falsificazione” (p. 97) nel paziente, affinché si possa osservare “fino a che punto il paziente trasforma ciò che percepisce in ciò che desidera" (p. 122), ossia un confronto tra la realtà esterna e quella interna (l'esame di realtà).
Il punto interessante é che, se è vero che è la relazione a rappresentare la vera fonte del processo di guarigione del paziente (Weiss, 1993), questo può avvenire solo attraverso un lavoro costante di ricerca della “verità” del paziente (l’insight), all'interno di un processo intersoggettivo di ipotesi e di continue verifiche (validazioni). D'altronde, quell'alleanza terapeutica che costituisce il fattore mutativo più importante per il paziente viene costruita non attraverso una relazione meramente di tipo suggestivo, idealizzato o seduttivo (per citarne alcuni), ma da quel sentimento di comprensione profonda che fa sentire al paziente di essere sintonizzato col terapeuta proprio durante la discesa (la catabasi) in quelle zone più oscure, intime, criptiche e spaventose di sé. E tale esplorazione può avvenire solo se il focus sull’inconscio permane durante tutta la relazione terapeutica affinché l'insight possa fortificare l'alleanza terapeutica che a sua volta facilita il processo dell’insight in una specie di circolo virtuoso. Ed è chiaro che in questa prospettiva la relazione terapeutica non può che basarsi su un totale clima di onestà, responsabilità etica e assenza di manipolazioni.
Mi rendo conto che questa posizione solleva inevitabilmente diverse questioni di più ampia portata: l’antico e spinoso problema del collegamento tra verità ed efficacia terapeutica, già ampiamente sollevato da Grünbaum (1984) attraverso “l’argomento della concordanza”; il rapporto tra suggestione ed efficacia terapeutica così antico da anticipare la nascita stessa della psicoanalisi (Ellenberger, 1970); il ruolo dell’insight come variabile indipendente nel processo mutativo della terapia rispetto alle varie forme di terapia basate sull’esperienza emozionale correttiva (Eagle, 2011).
Già tempo addietro Eagle (1984) sottolineava come la sfida, ancora tutta da dimostrare sul piano empirico e clinico, risiede nell’affermare come un’esperienza emozionale correttiva completamente slegata e indipendente dall’insight (erigendo solo la “relazione” come fattore curativo) possa avere un effetto terapeutico positivo di per sé. Infatti, per quanto si possa assegnare all’empatia un valore essenziale all’interno del trattamento e per quanto ci si possa affidare ad essa per la comprensione del paziente, inevitabilmente il clinico finisce per andare al di là dei concetti empaticamente derivati una volta che si trova ad operare all’interno del setting analitico (come l’analisi delle difese e delle resistenze, l'analisi del transfert, la ricerca di nessi causali attraverso l’interpretazione…).
D'altronde, come ha fatto notare bene Friedman (1988), lo stesso Freud (1912) non ha mai contrapposto la relazione e l’attaccamento all’insight (come fecero invece i posteri "freudiani" che spesso trasformarono l'analisi in una fredda e masturbatoria indagine intellettuale), bensì egli li vide sempre estremamente collegati in un’integrazione reciproca sintetizzata nella concettualizzazione, nella dinamica e nel lavoro inerente al transfert, ponte d’incontro tra passato e presente. Similmente Sterba (1934) parlava di “scissione terapeutica” tra un Io che vive l’esperienza analitica nella relazione col terapeuta ed un Io osservante che analizza, sintetizza ed integra durante quel processo di elaborazione che gradualmente é in grado di liberare nella persona nuove energie creative.
E’ ragionevole aspettarsi che le narrative o le interpretazioni che non sono particolarmente rilevanti per gli aspetti cruciali della vita del paziente e che non “parlano” alla sua esperienza, ma sono in gran parte dettate dalla fedeltà dell’analista a una particolare teoria, non abbiano un grande valore terapeutico. Quindi, l’efficacia terapeutica potrebbe non essere solo una funzione della mera coerenza della narrativa o della prospettiva teorica, ma anche, per dirla con Freud (1915-1917), del fatto che vi sia ‘concordanza’ con la realtà che è nel paziente, se per “realtà” si intende ciò che risuona con le esperienze e le preoccupazioni [prevalentemente inconsce] del paziente. (Eagle, 2022, p. 308)
Per cui, dando per assodato quanto già sintetizzato esaustivamente da McWilliams (2021) e per quanto ovviamente la terapia psicoanalitica resti irriducibilmente un’arte, perché possa continuare a mantenere il proprio potere terapeutico, essa (e quindi necessariamente anche la supervisione) deve continuare a focalizzarsi sull’importanza di comprendere innanzitutto la comunicazione inconscia che permea costantemente la coppia analitica. E la validazione degli interventi del terapeuta può quindi rappresentare uno strumento essenziale per controllare il buon andamento della terapia, soprattutto in quei tipici momenti critici o di stasi col paziente che spingono l’analista a portare il caso in supervisione, fino a diventare parte integrante del cosiddetto “supervisore interno” nella figura stessa dell’analista.
Codignola E. (1977). Il vero e il falso. Boringhieri, Torino.
Eagle M. (1984), La psicoanalisi contemporanea, Laterza, Roma, 1993.
Eagle M. (2011). Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Raffaello Cortina, Milano, 2012.
Eagle M. (2022). Verso una teoria psicoanalitica unificata. Raffaello Cortina, Milano, 2023.
Ellenberger H. (1970). La scoperta dell’inconscio. Bollati Boringhieri, Torino, 1976.
Freud S. (1912). Tecnica della psicoanalisi. OSF vol. 6, Bollati Boringhieri, Torino, 1986.
Freud S. (1915-1917). Introduzione alla psicoanalisi. OSF vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 1986.
Friedman L. (1978). Anatomia della psicoterapia. Torino: Bollati Boringhieri, 1993.
Glover E. (1955). La tecnica della psicoanalisi. Astrolabio, Roma, 1971.
Grunbaum A. (1984). I fondamenti della psicoanalisi. Il Saggiatore, Milano, 1988.
Langs R. (1985). Follia e cura. Bollati Boringhieri, Torino, 1988.
Langs R. (1988). Guida alla psicoterapia. Bollati Boringhieri, Torino, 1990.
McWilliams N. (2021). La supervisione. Raffaello Cortina, Milano, 2022.
Searles H. (1975). Il paziente come terapeuta del proprio analista. In Il controtransfert. Bollati boringhieri, Torino, 1994.
Sterba R. (1934). Il destino dell'Io nella terapia analitica. Psicoterapia e Scienze Umane, 1994, XXVIII, 2: 109-118
Weiss J. (1993). Come funziona la psicoterapia. Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Il Blog, che riceve migliaia di visualizzazioni giornaliere, contiene articoli coperti da diritti d'autore, ognuno dei quali proviene da mesi di scrupolose ed estese ricerche sul tema. Ciononostante si è scelto di divulgare tali studi in maniera completamente gratuita, senza la necessitò di affiliazioni obbligatorie ad istituzioni o riviste ed escludendo qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria. Si prega pertanto di fare buon uso di tale materiale, con l'augurio che tali contenuti possano rappresentare una fonte di stimolo per chiunque abbia interesse ad esplorare tutto ciò che riguarda quel curioso e misterioso fenomeno che è l'essere umano.
Commenti