28 nov 2025Tempo di lettura: 23 min


2 nov 2025Tempo di lettura: 34 min


13 lug 2025Tempo di lettura: 5 min
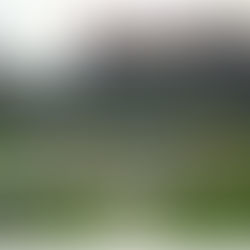

4 apr 2025Tempo di lettura: 6 min


16 mar 2025Tempo di lettura: 29 min



Aggiornamento: 9 ott 2022
Versione PDF stampabile:

"Il Diavolo prende il volo quando la donna gli mostra la sua vulva" (Freud, 1922, p. 416)
Fin dagli albori dei tempi la donna ha sempre rappresentato per l'uomo un enigma perturbante, un profondo mistero sempre dotato di una certa potenza (in quanto incomprensibile e quindi non controllabile), costituendo di conseguenza il fulcro di ricerche, speculazioni, indagini da parte di correnti psicologiche, filosofiche, religiose, sociologiche, antropologiche, politiche. Infatti, in ogni tempo e cultura, il principio femminile è sempre stato caratterizzato da un carattere ambiguo e oscuro, data la sua intima associazione con l'ignoto, l'Eros, la morte, la stregoneria, il sacro, il mondo degli spiriti e l'aldilà (Harding, 1971)... avendo cioè sempre rappresentato un "mediatore privilegiato delle conoscenze primarie del mistero della natura e dell'esistenza" (Magli, 1974, p. 72). Tuttavia tale atteggiamento in fondo non stupisce oltremodo, se si considera il fatto che di per sè la femminilità rimane sempre legata allo stato edenico perduto (per approfondimenti...) e più in generale a "conflitti profondi per ciò che riguarda il rapporto con la prima donna che abbiamo conosciuto, nostra madre, e la nostra identificazione con lei, quale che sia il nostro sesso" (Chasseguet-Smirgel, 1986, p. 14).
E anche la psicoanalisi non ha mancato di sostenere in modo dogmatico stravaganti asserzioni sulla concezione della donna (dimostrando spesso pregiudizi personali e culturali piuttosto che un atteggiamento genuinamente orientato analiticamente). Non a caso lo stesso Freud (1932) definiva la donna come il "continente nero" della psicoanalisi, esprimendo più volte il grado di incompletezza delle esplorazioni teoriche nei suoi scritti e la parzialità dei risultati ottenuti sino a quel momento: "Se volete sapere di più attorno alla femminilità, interrogate la vostra esperienza, o rivolgetevi ai poeti, oppure attendete che la scienza possa darvi ragguagli meglio approfonditi e più coerenti" (1931, p. 533). Sembra infatti che nemmeno Freud (figlio di un contesto storico e culturale specificatamente positivista e patriarcale), sia stato risparmiato da certe macchie cieche inerenti al materno, nel corso delle sue teorizzazioni intorno al tema (Atwood, Stolorow, 1993 [2]; Lopez, 1999 [4]; Gay, 1988 [5]; McDougall, 1995). D'altronde giova ricordare che fu proprio grazie alle donne che Freud potè costruire le sue prime intuizione psicoanalitiche: la stessa intensa "passione per l'ignoto, l'inconscio, fa pensare alla compenetrazione con il corpo materno, e all'isteria come linguaggio enigmatico, linguaggio del corpo [femminile]" (Cosnier, 1987, p. 29)
"Forse la donna è sempre stata un problema per l'uomo, ma mai come oggi è stata tanto 'problema' a se stessa. Della donna si parla, si discute, si scrive in tutti i campi, a tutti i livelli, dai giornali ai convegni politici, dai saggi alle interviste, ai libri di scienza; il discorso sulla donna appare, anzi, oggi, in un certo senso già logoro, perchè tutte le strade su cui si è impostato il problema tendono ad esaurirlo con soluzioni troppo univoche o radicali." (Magli, 1974, p. 3)
(Prima parte) - Premesse teoriche - Sviluppo psicosessuale - Invidia del pene, invidia del fallo - Lo spostamento narcisistico verso il padre - Il bambino dal padre e l'investimento libidico verso di lui - Il tramonto edipico e la graduale integrazione psicosessuale - La pubertà e la scoperta corporea della femminilità - "Destini" della femminilità in età adulta - Precisazioni: passività, frigidità, masochismo, depressione, morale, dipendenza
A scanso di equivoci, per intraprendere l'esplorazione di tale ampio tema, occorre fare alcune premesse e precisazioni.
Considerando l'intera storia sessuale delle forme viventi, per ragioni evoluzionistiche, nell'homo (e nella maggior parte degli animali omeotermi) la sessualità è arrivata a specializzarsi in una differenziazione di due soli sessi da un punto di vista biologico, anatomico e fisiologico (Wickler, Seibt, 1983). Diventa legittimo dunque presupporne una corrispondenza anche su un piano psichico, al di là delle diverse manifestazioni culturali che definiscono cosa sia maschile e cosa femminile in una data società (Butler, 1999 [10]), come d'altronde si riscontra attraverso la letteratura antropologica, mitologica, filogenetica. Così, in linea teorica, si può parlare di principio maschile (mascolinità) e di principio femminile (femminilità), che ovviamente non si presentano mai in forma pura ed esclusiva nell'uomo e nella donna, nè dal punto di vista biologico nè da quello psicologico (già Freud sottolineava come sia un errore far equivalere la femminilità alla sola donna e la mascolinità solo all’uomo).
Benchè "l'identità nucleare di genere" si stabilisca a partire da un'età molto precoce, intorno ai 15-18 mesi di vita (Stoller, 1968 [10]), la psicoanalisi ha mostrato come psicologicamente non si nasca come uomo o donna, in quanto femminilità e mascolinità rimangono due aspetti complementari di una vita psichica sempre inevitabilmente bisessuale nell’uomo e nella donna. In altre parole, i due sessi, per quanto caratterizzati dalla differenza, restano comunque soggetti "misti", in cui mascolinità e femminilità sono sempre amalgamati in diversa misura: "Non si tratta dunque soltanto di ammettere che ogni individuo, uomo o donna, è nello stesso tempo uomo e donna, ogni volta le due cose, ma di stabilire in quale misura ciascuno abbia 'solo un pò più l'uno o l'altra' (Freud, 1932, p. 221, in Chabert, 2003, p. 121). Ecco perchè Freud ha sempre preferito parlare di psicosessualità, ossia considerando sempre l'intima relazione tra il biologico e lo psicologico (corpo e mente), in cui, accanto alle influenze ambientali e culturali, mascolinità e femminilità necessiteranno di venire integrate nel corso di un lungo sviluppo, per l'appunto, psicosessuale.
Infine, nonostante la differenziazione sessuale sia già nota precedentemente al bambino, è con l'entrata alla fase edipica che il riconoscimento delle differenze tra i sessi raggiunge l'impatto psicologico più significativo, costringendo il bambino ad accettare, non senza dolore e sacrificio, l'impossibilità di appartenere ad entrambi i generi e di possedere entrambi i genitori (e quindi di orientarsi contemporaneamente in modo eterosessuale o omosessuale). Tuttavia, benchè il bambino si scontri così inevitabilmente con il proprio destino corporeo monosessuale, invidiando ciò che gli manca e che invece è posseduto dall'altro sesso (fatto che costituisce una delle più profonde ferite narcisistiche dell'infanzia), dal punto di vista psichico, tale bisessualità continuerà a permanere nella psiche dell'adulto. D'altronde, il dilemma dell'umano non consiste altro che in questo: voler essere tutto in modo onnipotente in una realtà definita da un corpo mortale e limitato (per approfondimenti...); ambizione che troverà il suo compromesso nella creatività (per approfondimenti...) e nell'amplesso genitale (dove psiche e soma ritornano temporaneamente fusi).
La scoperta da parte del bambino della differenza tra i sessi ha un corrispettivo, quanto a traumaticità, nella precoce scoperta dell'alterità e nella successiva rivelazione dell'inevitabilità della morte. Alcuni individui non riescono a venire a capo di questi traumi universali, e tutti noi tentiamo di relegarli, in maggiore o minor misura, nei più profondi recessi della mente, là dove siamo perfettamente liberi di essere onnipotenti, bisessuali e immortali!" (McDougall, 1995, p. 7)
Secondo la maggior parte degli autori, l'evoluzione del maschio e della femmina è quasi identica fino alla fase fallica (le fasi orali e anali sono praticamente sovrapponibili nei due sessi), nonostante vi siano tempi, capacità e atteggiamenti già distinti nella bambina rispetto al bambino, a causa della diversa pressione ormonale a cui i sessi sono sottoposti fin dalla nascita (Brizendine, 2006).
Nonostante la fase preedipica nella bambina duri più a lungo rispetto al bambino (per il suo attaccamento identificatorio con la madre), per entrambi i sessi la madre è l'oggetto d'amore esclusivo e ha caratteristiche idealizzate e onnipotenti, essendo "capace di tutto e dotata di tutti gli attributi di valore" (M. Brunswick, 1940). Ossia, in altre parole, entrambi i sessi nelle prime fasi si identificano primariamente con la madre idealizzata che soddisfa i loro bisogni in modo onnipotente, rimanendo l'oggetto su cui ricade ogni investimento libidico.
"L'omosessualità primaria della bambina la spinge a desiderare di possedere sessualmente la madre, di penetrare la sua vagina, di 'arrampicarsi dentro di le', di 'mangiarla per incorporare completamente il suo corpo, con tutti poteri magici di cui è dotato. La piccola vuole essere anche penetrata dalla madre, vuole fare un bambino con lei, e diventare così il suo unico oggetto d'amore, escludendo il padre." (McDougall, 1995, p. 4)
Anche con l'accesso della fase fallica, la madre rimane l'oggetto d'amore principale verso cui la bambina ha un atteggiamento attivo e possessivo (il padre è rivale e la zona erogena preminente è il clitoride): infatti tale fase si chiama fallica proprio perchè è il fallo (incarnato dal pene e dal clitoride) ad essere il protagonista assoluto della scena psichica per entrambi i sessi, segnando un punto cruciale dello sviluppo in due direzioni diverse nel bambino e nella bambina. Se infatti il primo continua ad investire sul pene come "garanzia di una riunione con l'oggetto amato" (Mitchell, 1974, p.121), la bambina si scontra con una sorta di "tragedia biologica" (Alizade, 2006), pensando che non l'ha ottenuto, l'ha perso, o che le crescerà più tardi (significazione anatomica). E' l'inizio cioè di una fase di invidia del pene: la sensazione di essere mancante di qualche cosa e l'impossibilità di disconfermare tale fantasia, fa sì che la bambina possa avvertire il proprio sesso come una specie di ferita (e le mestruazioni osservate nella madre ne diventano la prova schiacciante secondo l'associazione che lega emorragia e ferita).
Infatti, nonostante le controversie sul tema (Horney, 1967; Thompson, 1942; Klein, 1932; Jones, 1927), che sia onnipresente o che possa avere una natura anche difensiva (Chasseguet-Smirgel 1964; Luquet-Parat 1964; McDougall, 1995), di fatto l'invidia del pene nella bambina affonda le sue radici nelle pulsioni esibizionistiche e voyeuristiche tipiche di questa fase: il carattere nascosto dei propri genitali rispetto al maschio, lo scarso afflusso di sangue e l'assenza di secrezioni, le differenze osservate rispetto alla minzione, le limitate possibilità di stimolazioni erogene durante le varie esperienze di igiene e di gioco, forniscono alla bambina una scarsa rappresentabilità della propria vagina. Anche le prime esperienze masturbatorie sembrerebbero dare alla bambina solo vaghe sensazioni cenestesiche (Kestenberg, 1968 [6]), spesso confuse con gli organi interni del corpo (lo stomaco l'intestino) o con le zone confinanti (l'ano). Tutto ciò non consentirebbe alla bambina di costruire uno schema psichico ben definito del proprio corpo, con confini ben delimitati e con un'integrità sempre verificabile (come accade nel bambino): ella infatti potrà ottenere una piena "conferma" corporea della propria identità femminile solo con la pubertà. Ecco perchè Freud (1924) affermava che "l'anatomia è un destino", in quanto è sempre con l'osservabile (il pene), che la bambina si confronta continuamente, traendo le proprie conclusioni (castrato/non castrato): "la bambina galleggia nelle tenebre della propria anatomia genitale interna". (Bleichmar, 1994, p. 60)
"Anche se si pensa che le pulsioni femminili siano all'opera sin dall'inizio e che la bambina possieda un organo adeguato, di cui ha una più o meno chiara coscienza, resta non di meno vero che, sul piano narcisistico, la bambina si vive in misura variabile come dolorosamente incompleta." (Chasseguet-Smirgel, 1964, p. 182)
Ma perchè il fallo acquista una tale importanza psichica nel bambino/a?
Per due motivi: quello libidico, perchè il fallo rappresenta l'organo per mezzo del quale è possibile possedere attivamente la madre (e quindi realizzare il desiderio, da parte di entrambi i sessi, di ricongiungersi con lei - non a caso il fallo in mitologia è il simbolo della fertilità, della completezza e del desiderio sessuale); quello narcisistico, perchè permette di differenziare, separare, individuare la propria identità da quella della madre. Infatti, come ricorda la clinica delle perversioni (per approfondimenti...), il fallo costituisce la garanzia e la costante rassicurazione contro la minaccia dell'incorporazione e della fusione indistinta col materno (e quindi contro la perdita dell'Io). Una corrispondenza biologica sulla necessità di differenziazione dalla madre si trova anche dal fatto che "dal punto di vista embriologico il pene è una clitoride mascolinizzata; il fatto neurofisiologico è che il cervello maschile è un cervello femminile androgenizzato [cosa che accade a partire dall'ottava settimana del feto]" (Stoller, 1972).
Dunque nella bambina il momento del riconoscimento psichico di tale mancanza "si fonda sull'alterazione, sull'inversione della valorizzazione del suo genere, che da idealizzato e pieno perviene ad una condizione di inferiorità e di carenza" (Bleichmar, 1994, p. 90). Il padre diviene così colui che può riparare il suo narcisismo ferito (trionfo sulla madre preedipica onnipotente), e il pene (oggetto parziale) viene a costituire quindi il simbolo (il fallo) di potenza, autonomia, integrità, atto "contrastare il potere materno" (Chasseguet-Smirgel, 1962, p. 189). Dunque "il padre non è potente solo perchè ha il pene, ma perchè (con il suo pene) simboleggia la libertà dalla dipendenza dalla madre potente della prima infanzia" (Benjamin, 1988, p. 95). L'individuazione o la fusione indistinta "vengono ora organizzati all'interno della struttura di genere" (Benjamin, 1988, p. 103), in cui "la sua diversità [del padre] è simboleggiata e garantita dai suoi genitali diversi" (ibid., p. 107)
Il futuro sentimento d'inferiorità della donna rispetto all'uomo (mancanza del fallo) si può inscrivere proprio a partire da questo iniziale collasso narcisistico, derivante sia dal tramonto della madre ideale onnipotente con cui la bambina si era identificata, sia dalla frustrazione libidica nel potersi riunire con lei (a causa della mancanza del pene). Ed è dunque su questa base ontogenetica (in cui viene perduto l'ideale femminile) che la bambina avrà d'ora in poi la possibilità di compensare e integrare il proprio maschile mancante o, a seconda delle dinamiche famigliari e socioculturali, perseverare un'immagine svalutata del proprio genere (e continuare ad invidiare il fallo, sentendosi inferiore rispetto all'uomo).
"La svalorizzazione della madre, che accompagna inevitabilmente l'idealizzazione del padre, dà al ruolo di liberatore del padre un'implicazione particolare per le donne. Significa che la loro necessaria identificazione con le madri, con la femminilità esistente, sconvolgerà la loro lotta per l'indipendenza." (Benjamin, 1988, p. 102)

Dunque l'insufficienza del proprio organo fallico (castrato), che non le potrà crescere (come ad esempio accade osservando lo sviluppo fisico del fratellino), obbliga la bambina, "non senza dolore o protesta" (Mitchell, 1974) a seguire un'altra via: rivolgersi al padre per compensare il proprio narcisismo ferito e le proprie soddisfazioni libidiche (ed ecco perchè dietro all'amore dietro il padre si nasconde sempre l'intenso amore originario verso la madre).
Così, le spinte attive della pulsione vengono sottoposte a rimozione perchè "si sono dimostrate assolutamente irrealizzabili" (Freud, 1931, p.36), e perchè sono cariche di intensi moti aggressivi nei confronti della madre (che non le ha donato il pene o che gliel'ha strappato in precedenza). Il senso di colpa (Deutsch, 1944, Bonaparte, 1957) dunque rovescia nella direzione opposta gli organi a meta attiva (solitamente identificate con il seno, le feci, il clitoride), in organi a meta passiva (la bocca, l'ano, la vagina), con l'unico intento d'impossessarsi del grande pene paterno. E' in questo momento che la vagina (anzi, sarebbe più corretto chiamarla "cloaca", in quanto, come si diceva in precedenza, nell'immaginario della bambina essa resta ancora solo un orifizio misterioso, abbastanza indifferenziato con il clitoride e l'apparato urinario), inizia a diventare la zona su cui si spostano le precedenti caratteristiche ricettive della bocca e dell'ano (quindi miranti a ricevere, trattenere, prendere dentro di sè, contenere, espellere), corrispondenti alla fase orale e anale (Jones, 1927). Tale cambiamento è stato osservato anche nel mutamento del modo di giocare della bambina (rispetto al bambino), a cominciare da come ella sperimenta e proietta la "topografia del corpo umano" sullo spazio circostante di gioco (Erikson, 1964, p. 273 [3]).
Inoltre la spinta all'incorporazione del pene paterno (il desiderio carico d'aggressività di strapparlo al padre) o la volontà di rubarlo alla madre per contrastarne l'onnipotenza (Klein, 1932), per il fatto che il padre è l'unico oggetto d'amore "rimasto" dopo la delusione materna, per il timore di ripercussioni da parte della madre secondo la "legge del taglione", e soprattutto per l'intensa paura di subire lesioni all'interno del proprio corpo nel caso i propri desideri venissero soddisfatti (il coito fantasticato col padre), portano tali moti aggressivi a soggiacere a rimozione (e con essi l'invidia del pene) e a rovesciarsi difensivamente in desideri masochistici (cosa che nella donna adulta si può ancora rintracciare nelle fantasie di stupro o di essere violentata [Freud, 1919]). Ecco perchè l'angoscia di castrazione riguarda paure e fantasie relative a parti del corpo perdute, danneggiate o mancanti, e, su un piano simbolico, "per l'inconscio, ogni ferita narcisistica rappresenta a tutti i livelli, un equivalente della castrazione, in funzione del valore narcisistico attribuito dai due sessi al pene, appare allora evidente che anche le donne, come gli uomini, non smettano mai di temere la castrazione, perchè sempre possono perdere qualcosa che ha un significato fallico, anche se il pene è già stato 'perduto'" (Chasseguet-Smirgel, 1962, p. 190).
Tali angosce sono inoltre alimentate dalle varie fantasie relative alla scena primaria (il rapporto sessuale tra i genitori), che, oltre alle tipiche fantasie falliche inerenti alla paura di essere distrutti o di distruggere il partner, possono presentarsi "sotto forma di fantasie erotico-orali e di divorazione, di rapporti erotico-anali e sadico-anali, di confusioni bisessuali, di fantasie arcaiche di vampirizzazione, o come timore di perdere il proprio senso d'identità o la capacità di rappresentarsi i propri limiti corporei" (McDougall, 1995, p. 8). Sono paure che nella clinica dell'adulto si possono riscontrare in "delinquenti che irrompono sfondando finestre o porte; uomini col fucile che minacciano di sparare; animali che strisciano, volano o s'infilano da qualche parte (serpenti, topi, falene); animali o donne ferite con coltelli; treni che entrano in una stazione o in un tunnel" (Horney, 1967, p. 177).
Chiaro che il livello d'angoscia rispetto al pene paterno (e quindi la carica aggressiva rimossa nei suoi confronti) dipende in larga misura da quanto in precedenza la madre ha rappresentato per la bambina una potenza onnipotente, invadente e destrutturante (madre fallica). Il pene diventa cioè il nuovo bersaglio dell'ambivalenza originaria verso la madre preedipica: idealizzato e dotato di una "potenza senza limiti, sia in bene che in male, che garantisce, a chi lo possiede, sicurezza e libertà assolute, immunità dall'angoscia e dalla colpa, possibilità di godimento, amore e attuazione di ogni desiderio" (Torok, p. 222). Ma proprio per questa potenza fallica smisurata, esso può assumere altrettante caratteristiche minacciose e pericolose (e saranno solo la tenerezza e l'affetto usate dal partner durante la deflorazione nel primo rapporto sessuale, a disconfermare tali fantasie nella ragazza, che potrà così abbandonarsi senza pericoli al piacere della propria femminilità).
A questo punto, la soluzione di compromesso a tali angosce e all'impossibilità di avere il pene, segue l'equazione simbolica del linguaggio che la bambina conosce a quell'età (quello dell'inconscio), che fa equivalere il pene alla possibilità di avere bambino dentro il proprio grembo (così come nella fase anale le feci erano dentro la pancia, il latte dentro la bocca), completando la catena associativa capezzolo/latte/bocca-pene/seme/bambino. Già Freud (1905) infatti aveva osservato come i bambini di entrambi i sessi, ancor prima del problema sulla diversità sessuale, fantasticassero sul generare figli o donare figli ai genitori, spinti dall'enigma sulla provenienza dei bambini. Ecco quindi che alla fine della catena associativa, secondo la celebre espressione, il figlio diventa il "fallo mancante della madre" (Lacan, 1956), e la maternità, per il suo inestimabile valore simbolico, diverrà così nella donna adulta un imperativo psichico che affonda le sue radici sul piano biologico esclusivo del femminile.
"Quando il bambino attribuisce il pene al padre e alla madre, o quando attribuisce il pene anche alla bambina, quando immagina che esista un unico genitale, il fallo maschile, oppure che la madre contenga dentro di sè anche il fallo paterno, il bambino non vive alcuna contraddizione tra tutte queste situazioni. Nè avverte alcuna contraddizione quando nelle sue fantasie confonde i rapporti sessuali con l'aggressione oppure si identifica con il padre e con la madre per mettere al mondo se stesso, così come non avverte contraddizione quando nella sua mente il pene, il senso, la vagina e la bocca, la vagina e l'ano, l'ano e l'orecchio si sostituiscono l'un l'altro e così via. Ciò s'incontra con il fatto che l'aspetto più importante della scoperta freudiana della sessualità infantile è quello relativo al fatto che essa è soprattutto espressione di un linguaggio simbolico, che alimenta tutte le strutture dell'immaginario." (Fornari, 1976, p. 163)

Dunque la bambina, diventando la rivale edipica della madre nella lotta per la conquista del padre-uomo, "vorrà essere non solo una 'mamma' come sua madre, ma anche moglie del suo 'papi come lo è la 'mami', non accontentandosi più di essere semplicemente la bimba di 'mami' e 'papi': vorrà essere 'la mami dei bambini del suo papi'" (Bleichmar, 1994. p. 92). In altre parole, la bambina non vuole più essere come il padre (e avere anche lei il pene), ma desidera avere il padre, orientandosi quindi verso "l'amore eterosessuale, amore di ciò che è diverso" (Benjamin, 1988, p. 109). E la madre, pur essendo rivale, rimane tuttavia il modello a disposizione della bambina per poter far breccia nel desiderio del padre: "è fenomeno comune che le bambine odino la madre per poter essere l'unico oggetto d'amore del padre, ma cerchino al tempo stesso d'identificarsi con la madre e di rassomigliarle, proprio allo scopo di conquistarsi l'affetto paterno" (Deutsch, 1944, p. 285).
E dato che la bambina ha bisogno di sentire la sua femminilità valorizzata dal padre come quella della madre (sua moglie), ella impara ben presto "l'arte della seduzione" (ossia cerca d'inseguire ciò che desidera il padre dalla donna), per assicurarsi così di essere anche lei desiderata, amata e "scelta" (e per la vaghezza del proprio sesso, è l'intero corpo a venire erotizzato nel contatto fisico col padre): "la bambina scopre molto presto l'ammirazione e i privilegi che le derivano dal possedere o amministrare la sua bellezza (...) [capendo che] quanto più si è belle, tanto più si è apprezzate, amate, desiderate" (Bleichmar, 1994, p. 91). Di fatto, se la donna è stata spesso accusata di maggiori bisogni narcisistici (attenzione, dimostrazioni d'amore, corteggiamenti...) e di una maggiore vanità attraverso il culto della propria della bellezza, è dovuto anche al fatto che in questa fase, l'essere amata possiede a livello inconscio il significato simbolico dell'ottenimento del fallo/bambino (e quindi il corpo diviene rappresentazione fallica del potere narcisistico e libidico).
"[Il corso dell'amore] ha inizio, esattamente come accade negli uomini, con fantasie di regresso alla prima fase di dipendenza alla madre che dà al figlio calore, protezione, rifugio e alimento. L'inconscia fantasia della donna in tal modo regredisce al regno dei desideri iniziali: essere stretti e abbracciati, cullati, protetti. In tali fantasie, la donna torna all'infanzia. In seguito l'uomo assume, nelle fantasie femminili, il ruolo un tempo svolto dalla madre, primo oggetto d'amore. Più tardi ancora, l'eterno desiderio di essere 'curata dalla madre' è sostituito da quello di assumere il ruolo della madre e diventare madre a sua volta; per un fatto d'identificazione, la donna ora vuole avere un figlio, prendersi cura di lui e cullarlo, anzichè esser lei figlia. La transizione da questa fase iniziale alla fase finale della fantasia è rappresentata dall'uomo. Il quale è, per così dire, il ponte che collega l'una fase all'altra. Egli non solo darà alla donna il figlio che desidera, ma sarà egli stesso il figlio sul quale, nel frattempo, essa riverserà il suo amore." (Reik, 1961, p. 299-300).
Dunque al termine di tale sviluppo, l'accettazione della castrazione la inserisce nel pieno registro femminile alter rispetto a quello maschile, ossia nell'ordine non più dell'avere o non avere, ma dell'essere una donna (Fromm, 1949), a partire dalla presa di coscienza dell'importanza che la maternità conferisce al suo corpo esclusivamente femminile. Tuttavia alla fine la bambina dovrà accettare che non solo non diventerà un uomo, non possederà mai la madre e non farà mai dei bambini con lei, ma che non potrà nemmeno mai avere per sè il padre e un bambino con lui. Tale delusione respingerà di nuovo la bambina verso la madre, che solo fungendo da buon modello d'identificazione nel suo divenire donna (e tornando quindi ad essere riqualificata dopo la precedente svalutazione), le consentirà di accettare di entrare nello stesso registro (femminile) d'appartenenza, senza che l'identificazione con lei possa metterne a repentaglio l'indipendenza (come accade ad esempio quando il ruolo della donna/madre viene svalorizzata all'interno della famiglia). Processo tuttavia mai scevro da conflitti e ambivalenza, in quanto la donna dovrà far fronte alla "necessità paradossale di separarsi e simultaneamente identificarsi con la madre" (Benjamin, 1988, p. 119); colei che, nel corso del suo sviluppo, ha avuto la duplice funzione di cura (anaclitica) e di identificazione (ideale): "la madre non è solo l'oggetto dell'amore, della dipendenza assoluta, ma anche l'ideale narcisistico e il proprio simile di genere." (Bleichmar, 1994, p. 75)
"La bambina impara che avrà un figlio, non perchè è forte, energica, piena d'iniziativa, nè perchè lavora, lotta e alla fine ha successo, ma semplicemente perchè è una bambina e non un bambino, e perchè le bambine diventano donne, e se proteggono la loro femminilità, alla fine hanno un figlio." (Mead, 1949, p. 84)
Inoltre, se il legame preedipico con la madre non ha subito esagerate problematiche, è il rapporto di costante e adeguata tenerezza col padre a costituire "il clima nel quale la sessualità femminile si evolve nel migliore dei modi" (Bonaparte, 1957, p. 163), e senza troppe ripercussioni derivanti dall'ineluttabile rifiuto edipico (ossia la constatazione che i genitori non possono essere separati dal desiderio della bambina, che rimane esclusa da un legame esclusivo tra i genitori). Infatti è noto come esperienze troppo seduttive o forti conflitti coniugali che portano i genitori a distanziarsi (fornendo alla bambina false speranze di vittoria contro il rivale edipico), sono legate, nella vita adulta, a coazioni a ripetere nevrotiche di tale antica triangolazione: cosicchè "nel suo più vero essere donna, cioè nell'amore femminile eterosessuale, la bambina si ritrova castrata, sedotta e respinta." (Mitchell, 1976, p. 147)
Infatti il padre permette contemporaneamente alla bambina sia una maggiore valorizzazione della sua femminilità come donna, sia un'integrazione del maschile (attraverso l'identificazione con lui), stabilendo in questo modo una migliore separazione della madre (senza tuttavia disidentificarsi con lei), e dando la possibilità alla futura ragazza di formare sublimazioni attive (avendo introiettato l'aspetto fallico del padre). La mancanza di tale integrazione relazionale col maschile impedisce alla bambina di viversi come completa e non più mancante di qualche cosa: "quando un padre non permette una identificazione omoerotica alla figlia, quando cioè non permette alla figlia di esplorare il mondo, di gioire dell’avventura e di aprirsi al mistero e alla scoperta, come fa lui, le nega inevitabilmente di viversi come soggetto" (Bleichmar, 1994. p. 112).
Ecco perchè senza tale possibilità relazionale con il padre, che "deve tentare là dove sua madre non è riuscita: conciliare soggettività e femminilità" (Benjamin, 1988, p. 120), la donna continuerà ad avvertire una "mancanza" in cui "al desiderio di identificazione rimasto insoddisfatto subentra l'invidia [del pene]" (Benjamin, 1988, p. 109)
"Se l'originaria relazione simbiotica madre-figlia è difficile, la donna esigerà con maggiore insistenza, dal padre prima e dal marito come partner sessuale poi, la soddisfazione delle precoci frustrazioni edipiche. Ma, secondo Freud, anche quando il padre affronta con empatia i bisogni della figlia frustrati dalla madre, vi sarebbero spesso conseguenze negative sul rapporto col futuro partner eterosessuale: ne potrebbe infatti conseguire un esagerato legame con il padre, al confronto del quale ogni altro rapporto risulta deludente." (Mitscherlich, 1985, p. 76)
Quindi entrambi i genitori, se non vengono contrapposti in modo dicotomico nella rappresentazione della bambina, "possono essere simbolo di separazione e di attaccamento per i loro figli" (Benjamin, 1988, p. 111), diventando entrambi mattoni fondamentali per la costruzione del Sè, senza che le duplici identificazioni corrano il rischio di confondere le rispettive identità di genere. Infatti, se nelle rappresentazioni della bambina si crea un'opposizione troppo marcata tra una madre simbolo di dipendenza e vicinanza, e un padre simbolo di indipendenza e autonomia (ossia tra un principio femminile identificato solo nella donna e un principio maschile solo nell'uomo), allora da donna dovrà scontrarsi col fatto che "diventare soggetto di desiderio comporta il rifiuto del ruolo materno, della stessa identità femminile" (Benjamin, 1988, p. 135). Similmente, se una madre ad esempio ha idealizzato tutto ciò che è maschile (sviluppando quindi un'intensa invidia del pene latente), atteggiandosi in famiglia in modo masochistico, può creare una forte confusione nella bambina, in quanto svalorizzando il femminile opera una svalutazione anche della sua stessa persona. (Mitscherich, 1985)
"La bambina ha percorso un'evoluzione, che, a partire dal desiderio di avere un pene come il padre (dove il desiderio del pene è una riedizione secondo modalità pseudogenitali del desiderio pregenitale di potenza fallica, di possesso fallico e di partecipazione fallica primitiva) per penetrare nella madre, dal desiderio di prendere al padre il suo pene, giunge al desiderio di ricevere un bambino dal padre. Con l'aiuto del sentimento di tenerezza nei confronti della madre e delle identificazioni non conflittualizzate con lei, la bambina diviene capace - momento questo essenziale della sua vicenda - di un vero amore per il padre (e per il maschio), oggetto diverso da lei, detentore di un pene di cui si riconosce e si accetta priva. Ella ha acquistato, grazie all'investimento del proprio sesso reale, la possibilità di attuare il proprio amore nella complementarietà con l'altro. Solo ora l'eterosessualità viene conseguita. L'uomo, ad immagine del padre, è qui l'altro, diverso da lei e complementare, e proprio per questo amato e desiderato. Il mondo genitale, la genitalità, sono raggiunti." (Luquet-Parat, p.151)
"Nel quadro confuso dell'adolescenza molte cose diventano più chiare se sappiamo riconoscere, in tutto ciò che accade durante questa fase, il conflitto tra due mondi. Di questi due mondi, uno appartiene al futuro, cioè all'età adulta, l'altro al passato, cioè all'infanzia; il presente è un periodo di lotta per mettere queste due fasi della vita in relazione armonica l'una con l'altro, [ossia] il funzionamento delle forze progressive e regressive." (Deutsch, 1944, p. 112)

A seguito della fase di latenza, in cui la sessualità è quasi "congelata" come nella Bella addormentata che attende, quiescente, il tempo propizio per il suo risveglio, con la pubertà la giovane donna deve imbattersi con i cambiamenti stravolgenti del corpo innescati dai bombardamenti ormonali in atto (una diversa distribuzione del pannicolo adiposo, il menarca, la crescita dei fianchi, del seno, dei peli...), che le mostrano d'improvviso lo sbocciare della sua femminilità. E tali mutamenti, durante tutto l'arco dell'adolescenza, rimettono in causa il problema dell'identità sessuale (e l'oscillarsi degli impulsi bisessuali che la accompagnano), proprio perchè si impongono attraverso il corpo, a prescindere dall'immagine che la giovane donna si è costruita nella relazione con il maschile e il femminile. Ed è soprattutto l'arrivo della prima mestruazione a segnare l'entrata nel registro del femminile a tutti gli effetti, in quanto essa costituisce la possibilità reale (e non più solo fantasticata) di poter essere in grado di generare la vita.
"E' la concreta realtà del corpo femminile, vissuta come essere e avere un tesoro da offrire, che fonda la femminilità, recuperando nella propria appartenenza corporea ciò che nell'infanzia era vissuto come alienità che spingeva all'appropriazione predatoria del corpo materno, il tesoro perduto contenitore di ogni cosa buona." (Fornari, 1976, p. 164)
Inoltre l'entrata nella vita adulta intensifica un conflitto che durerà parecchi anni prima di trovare un adeguato equilibrio: da una parte il desiderio di rimanere bambina (essendo ancora fortemente incerta e bisognosa di protezione e di una direzione), dall'altra il desiderio d'indipendenza e soprattutto d'individuazione, con l'ambizione di intessere relazioni amorose intense che non siano solo una "riedizione" dell'attaccamento erotico verso gli antichi oggetti genitoriali (con cui la relazione assume aspetti più più immaginari che reali). E per il raggiungimento di tali fini, la ragazza tenta di riparare, consolidare o integrare le antiche identificazioni genitoriali (i suoi oggetti interni), attraverso nuove figure importanti con cui identificarsi, come transitori personaggi di fantasia presi dal cinema o i protagonisti di un libro (atti a ricreare una nuova edizione correttiva del vecchio "romanzo famigliare"). Allo stesso tempo, gli stretti legami con le amiche coetanee (caratterizzati prevalentemente da un amore omosessuale di stampo narcisistico), sono finalizzati soprattutto ad esplorare le nuove trasformazioni corporee in atto (e le sue ripercussioni in termini psicologici e relazionali), ed a rafforzare il senso di femminilità lungo la strada per diventare donna (attraverso l'identificazione con un'altra persona simile a se stessa). Infatti in questa delicata fase, tra madre e figlia risorgono gli antichi conflitti di separazione-individuazione: l'identificazione con la madre come tappa evolutiva del suo sviluppo nella formazione di una propria identità, è resa più complicata dal fatto che da un lato la giovane adolescente va sempre più separandosi e differenziandosi da lei in termini psicologici, dall'altro, crescendo e sviluppandosi, inizia però sempre più ad assomigliarle nella sua femminilità. Inoltre per molte madri è dura accettare i desideri di autonomia e d'individuazione delle loro figlie, e così "cercano di protrarre fino all'età adulta lo stretto rapporto con le figlie, nel quale ricercano una sostituzione delle proprie frustrazioni matrimoniali e/o ripetono comportamenti inconsci delle loro stesse madri" (Mitscherilch, 1985, p. 49). E il fatto che tali madri tendano a considerare le figlie più come parti di se stesse (ossia come estensioni narcisistiche), che come singoli individui dotati di specificità caratteriali e bisogni personali, incentivano nelle figlie atteggiamenti di dipendenza ed acquiescenza che rendono ulteriormente complicata la separazione materna.
In generale, tutto il periodo dell'adolescenza servirà alla ragazza per costruirsi una propria identità e per liquidare le tracce edipiche rimaste, fino al faticoso raggiungimento della genitalità, in cui tutte le precedenti pulsioni parziali vengono integrate nel pieno riconoscimento e nella valorizzazione del proprio sesso. Traguardo che ovviamente si raggiunge solo in linea teorica al termine dell'adolescenza, in quanto nell'attuale scenario della contemporaneità, è molto più verosimile che una piena separazione dai legami infantili e l'elaborazione dei "lutti" derivanti dall'integrazione dei propri oggetti interni (che non possono essere sempre riparati), avvengano solo con il raggiungimento della mezza età.
"In ogni fase dello sviluppo femminile si può constatare quale grande parte abbia nella vita psicologica di una donna l'attaccamento alla madre. Molti episodi della sua esistenza sono manifestazioni di sforzi fatti per troncare questi vincoli; sforzi compiuti in modo saltuario e dal cui esito più o meno felice dipendono spesso l'equilibrio psicologico e il destino della donna" (Deutsch, 1944, p. 21)
"Il carattere maschile e quello femminile coesistono all'origine in ogni essere umano; il sesso predominante accentua più o meno l'uno o l'altro, e le esperienze infantili, in un secondo momento, si limitano a costruire le loro reazioni su questa base, dove il carattere bisessuale, in senso lato, resta biologicamente primitivo." (Bonaparte, 1957, p. 23)

Oltre all'influenza determinante delle psicodinamiche evolutive individuali nell'interazione costante con l'ambiente famigliare e socioculturale, la femminilità procede necessariamente anche per una strada dettata dalla diversa bisessualità costituzionale di ogni donna, in cui la biologia continua a rivestire una certa importanza (compiacenza somatica). Infatti nella donna molto spesso i conflitti inerenti alla femminilità si manifestano su ciò che il corpo le ricorda essere una prerogativa esclusivamente femminile, ossia attraverso i disturbi mestruali (da tempo sono noti i possibili disturbi somato-psichici durante il periodo mestruale, tanto da possedere oggigiorno una categoria dedicata nel DSM-V sotto forma di "disturbo disforico premestruale"), i vari disturbi ginecologici durante il coito (vaginismo, dispareunia, frigidità), le vicissitudini avverse durante la gravidanza (come si vedrà nella seconda parte dello scritto).
Dunque il lungo percorso che deve attraversare la donna nel proprio sviluppo psicosessuale (che per l'appunto possiede una maturazione autonoma rispetto all'anatomia), può essere tutt'altro che diritto e privo di diramazioni rispetto al suo "destino" biologico: esso può infatti percorrere diverse vie (sovrapponibili e trasversali in ogni organizzazione di personalità), e, come in ogni altro fenomeno umano sovradeterminato, dipenderà dal conflitto delle varie forze in gioco, la "scelta" di una strada piuttosto che un'altra. E così, al pari delle pulsioni che la animano, la stessa femminilità può subire diversi "destini" (rimozione, repressione, formazione reattiva, sublimazione, conservazione):
- Può caratterizzarsi dalla tipica configurazione isterica, in cui la fissazione all'invidia del pene domina la scena, soprattutto attraverso l'espressione somatica (come ad esempio nel sintomo incorporativo del globus hystericus). Ciò che è tipico in tale donna è l'intensa ambivalenza nei confronti del maschile, la cui idealizzazione cela in realtà un rancore "simile alla nascosta ostilità dell'operaio contro il padrone ed i ai suoi sforzi per sconfiggerlo o per indebolirlo psicologicamente con i mille mezzi della guerriglia quotidiana" (Horney, 1967, p. 83). Infatti, la persistenza della delusione edipica e la sensazione di essere stata deprivata e ferita, la rendono incapace di lasciarsi andare in un rapporto di profonda intimità con gli uomini (sempre visti con sospetto, timore, ostilità), verso i quali cova latenti sentimenti di vendetta e di rivincita (la "donna rivendicativa" [Freud, 1931]). E l'unica modalità che ella conosce per ristabilire il proprio narcisismo e la propria soggettività, consiste nel rovesciare il potere dell'uomo, con l'intento di castrarlo simbolicamente (ossia di ridicolizzarlo o impoverirlo), o avanzando continue richieste ed esigenze (insaziabilità di dimostrazioni d'amore), che altro non rappresentano che "una richiesta inconscia di compensazione per i torti subiti" (ibid., p. 84). Tutti scopi che trovano nel terreno della sessualità l'occasione propizia per compiersi: che sia sottraendosi o procrastinando l'atto sessuale come una sorta di concessione, rendendo impotente l'uomo nel proprio desiderio (attraverso i vari disturbi ginecologici), o negandogli la possibilità di donarle piacere (frigidità), tale donna si raffigura il rapporto alla stregua di una lotta di genere (non di rado ella può raggiungere l'orgasmo solo stando sopra all'uomo, appagando la fantasia di sottometterlo e di averlo "sotto" di sè). Oppure, al pari del Don Giovanni, tale donna si affanna per sedurre un gran numero di uomini per poi rifiutarli una volta conquistati: in tal modo ella tenta di ribaltare la situazione di delusione edipica subita, mettendo da parte l'uomo conquistato come a suo tempo è successo con lei, quando si è sentita prima sedotta eppoi respinta (e dunque il fatto di essere sempre e solo lei quella desiderata è un modo per conservare una posizione di supremazia rispetto all'uomo).
Inoltre in tale donna è frequente riscontrare un "travestimento" difensivo (Riviere, 1929) attraverso una maschera di stereotipata femminilità (ostentata in modo teatrale e parossistico), "allo scopo di allontanare da sè l'angoscia e il timore delle ritorsioni che potrebbero subire da parte degli uomini [a causa dei propri intensi moti aggressivi inconsci]" (p. 89), e al fine di sventare la possibilità che la propria invidia venga scoperta, soprattutto in quegli ambiti culturalmente più di stampo maschile, come certe attività professionali a carattere competitivo.
- Può assumere connotati di stampo ossessivo/idealistico/ascetico, perdendo cioè il suo aspetto sensuale e fisico (la "donna rinunciataria", Freud, 1931): la verginità viene eletta come ideale narcisistico di purezza, e in onore di essa la donna sacrifica il proprio desiderio e spesso l'intera vita affettiva (che rimane così atrofizzata), pur continuandosi a sentire incompleta e infantile. L'erotismo diviene immateriale e la verginità si mantiene contro ogni dipendenza dal maschile e dal desiderio: da un punto di vista mitologico infatti, l'imene intatto "abbatte i diritti ancestrali di proprietà dell'uomo sulla donna" (Alizade, 2006, p. 109), come le Amazzoni, vergini guerriere "che non hanno ceduto alla debolezza della carne e che mantengono la loro forza attraverso una vagina intatta, che dà a i loro corpi una garanzia di potere" (ibid., p.108).
Nella storia infantile di queste donne l'intera sessualità spesso ha assunto un aspetto pericoloso e osceno, dove il proprio genitale, con i suoi aspetti incontrollabili (odori, secrezioni, mestruazioni...), è stato particolarmente contaminato da massicce caratteristiche anali (Salomè, 1916), facendo di tutto il corpo (per quanto esteticamente "perfetto") una fonte di disgusto, vergogna e imbarazzo, da gestire sempre attraverso forme di esagerato pudore.
- Può essere strumentalizzata a solo scopo narcisistico (per approfondimenti...), soprattutto nei suoi aspetti sensuali, estetici, fisici (il corpo conserva l'originario valore fallico). Tale donna vuole essere bramata ed esaltata per glorificare il proprio Sè, che diviene narcisisticamente il fulcro di ogni investimento, il cui fascino enigmatico ricorda "autosufficienza e inaccessibilità, analogamente all'interesse suscitato da certi animali, che non sembrano occuparsi di noi, come i gatti e i grandi animali predatori" (Freud, 1914, p. 32). Ella infatti, al pari di Carmen dell'opera di Bizet, può apparire tenebrosa, sanguigna, aggressiva, fredda, irraggiungibile (la femme-fatale), come se fosse un'opera d'arte da rimirare: spesso incapace d'amare, cerca continuamente l'estasi dell'innamoramento attraverso un'idealizzazione della relazione amorosa (che non può che essere di breve durata), come la figura della sirena che "con la sua musica ed il suo fascino attira l'uomo nell'acqua che sarà la sua tomba" (Harding, 1933, p. 54).
T. de Lempicka, Ragazza in verde (1932); E. Munch, Madonna (1895); G. Klimt, Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907); S. Botticelli, La nascita di Venere (1485); E. Manet, Berthe Morisot con un mazzo di violette (1872); F. Kahlo, Autoritratto con collana di spine e colibrì (1940); E. Maet, Olympia (1863); A. Warhol. Marilyn Monroe (1967); J. Vermeer, Ragazza col turbante (1665); P. Picasso, donna che piange (1937).
- Può inflazionarsi nella sua dimensione materna e anaclitica e confinarsi nel recinto del gineceo, raggiungendo tonalità depressive e masochistiche improntante alla dipendenza (per approfondimenti...): "se infatti la donna nega la sua femminilità e, da tesoro genitale, la fa diventare oblatività materna, il partner genitale viene trasformato in bambino, in base alla fantasia che, siccome il bambino non potrà mai vivere da solo, non potrà mai fare a meno di una mamma che si sacrifica per lui e pertanto la donna non sarà mai abbandonata dall'uomo" (Fornari, 1976, p. 168). Tale donna è il prototipo che fin dagli albori dei tempi la cultura ha cercato di plasmare nella suddivisione dei sessi, ossia cucendole addosso l'unico destino di "essere amata, amare un uomo, ammirarlo, servirlo e adattarsi a lui; come non donna non deve desiderare altro" (Mitscherlich, 1985, p. 69).
In tal modo la donna troverà una conferma narcisistica solo in funzione di quanto piacerà all'uomo come oggetto di desiderio, facendo dell'amore romantico un cardine centrale della propria vita: la meta suprema sarà quella di diventare la controparte di un uomo (l'oggetto ideale da possedere) a cui dedicare tutta se stessa, come un "cristallo prismatico" (Harding, 1933) che inconsciamente utilizza quella faccia di sè che meglio si adatta al desiderio dell'altro. E così si sforzerà d'incarnare il ruolo di moglie perfetta in accordo con gli ideali dell'uomo, vivendo per procura i tratti del carattere e il potere sociale che ella avrebbe voluto per sè: "la donna perde se stessa identificandosi con l'altro potente che incarna il desiderio e l'autonomia che a lei mancano: l'uomo le darà accesso a un mondo che altrimenti le sarebbe precluso" (Benjamin, 1988, p. 114)
- Può venire interamente svalutata rovesciandosi nell'emulazione del maschile (la donna fallica): si può supporre che tale donna sia rimasta a quel tempo dello sviluppo in cui "dopo essere andata oltre il primo tentativo di chiarirsi la mancanza del pene, considerandola come una punizione personale, e dopo aver compreso la generalità di questo carattere sessuale, la donna comincia a condividere il disprezzo dell'uomo per questo sesso minorato in un punto decisivo" (Freud, 1925, p. 212).
Siccome la madre ha fallito nel diventare un valido oggetto di identificazione, per tale donna appartenere al proprio sesso significa non essere nulla: in quanto "uomo mancato" (McDougall, 1964), il "concavo" viene aborrito per la conservazione del "convesso", dato che la vagina (e tutto ciò che simbolicamente le ruota attorno in termini femminili) non è mai arrivata ad acquisire alcun valore erogeno e narcisistico (Bonaparte, 1957).
Perciò di frequente accade che, per compensazione, ella viva esclusivamente per il successo professionale, evitando qualsiasi tipo di competizione nella sfera erotica (per l'ossessione di non poter piacere), di modo da non dovere di nuovo venire ferita nel proprio narcisismo femminile con un altro rifiuto: "la scelta dell'uomo da amare è resa difficile dal fatto che queste donne preferiscono i tipi passivi, salvo poi a spingerli ansiosamente perchè diventino attivi e perseguitarli con l'eterno rimprovero di non essere abbastanza energici" (Deutsch, 1944, p. 279). Infatti, nonostante sembri che sia il maschile a venire idealizzato, in realtà tale soluzione rispecchia il tentativo inconscio di ripristinare la rappresentazione onnipotente della madre fallica, che rimane in grado di generare da sola (rendendo quindi inutile la presenza dell'uomo in quanto altro sesso).
- Può continuare ad essere idealizzata, rinunciando alla sua meta (maschile), e restando quindi fissata al primo oggetto d'amore materno (omosessualità). In letteratura clinica se ne riscontrano di frequente due forme: nella prima, la donna conserva i caratteri della femminilità, instaurando con la partner il ruolo di bambina-madre o madre-bambina (attrazione quindi per le ragazze più giovani o le donne più anziane, o entrambi di questi ruoli), al fine cioè di ristabilire relazioni incentrate su una tenerezza che ricalchi lo stampo materno (prevalentemente a carattere orale passivo/ricettivo); nell'altra, la donna cerca di assumere aspetti mascolini per incarnare il ruolo maschile (identificazione paterna) nella relazione con l'altra (il carattere orale della relazione ha tonalità attive spostate sulla lingua; la penetrazione posticcia simulata ricala la rappresentazione del fallo fecale).
Nella storia delle donne omosessuali emerge spesso un quadro (supportato da motivi costituzionali) in cui il padre "non viene nè idealizzato nè desiderato: egli è detestato. Viene inoltre descritto come un essere ributtante, rumoroso, brutale e violento" (McDougall, 1964, p. 279): di conseguenza la madre diventa un oggetto non conflittualizzato, ossia l'oggetto completamente buono in opposizione al padre "cattivo" (una situazione quasi ribaltata rispetto a quella che si trova a vivere la "buona isterica"). In altre parole, se il padre idealizzato (nel momento in cui la bambina si rivolge a lui come nuovo oggetto amoroso), reagisce con esagerata freddezza, distacco o, peggio ancora, con violenza, allora la bambina, ulteriormente frustrata e intimorita (dato il pericolo e la poca attrattiva che egli esercita come oggetto eterosessuale), può inibire la propria femminilità e tornare a rivolgere gli investimenti libidici verso la madre, considerando nuovamente il padre come rivale (e identificandosi quindi con lui). Inoltre il padre in quanto uomo viene spesso dipinto come di scarso valore o insignificante, svalutato nella sua mascolinità: egli così, diventando simbolicamente inutile in quanto impotente, perde il suo aspetto fallico desiderato, conservando solo gli aspetti prevalentemente sadico-anali (e quindi pericolosi).
- Può venire rifiutata in senso letterale (concreto), quando il sesso corporeo (quello anatomico) viene percepito come opposto all'identità di genere psicologica (transessualismo): il corpo è sì riconosciuto per quello che è, ma viene visto come una deformità. Le ricerche sull'identità di genere svolte da Stoller (1968) [1] e Limentani (1989) [7] mostrano come tali fenomeni abbiano origine molto presto nello sviluppo del bambino, a partire dalle prime relazioni con la madre (a seconda di come investe i genitali e il sesso della figlia). Infatti, la "scelta" transessuale spesso è intrapresa per far fronte a incombenti minacce (psicotiche) riguardo alla propria identità: quando ad esempio la madre non riesce a sopportare il corpo di donna della propria bambina, la figlia può finire per accettare di essere un maschio nel corpo di una femmina, cercando, da adulta, di cambiare sesso nella speranza di venire finalmente riconosciuta in quanto persona (inconsciamente dalla madre), e potere quindi esistere come individuo.

Come ha ricordato Freud (1932), far equivalere la passività alla donna sarebbe un grossolano errore, in quanto attività e passività sono solo le qualità di una pulsione presente in entrambi i sessi: sarebbe più giusto invece accostare l'essenza della femminilità con la ricettività (che nulla a che vedere con l'inerzia), da intendere come forma di attività a meta passiva (la stessa vagina è continuamente attiva durante il coito da un punto di vista fisiologico). Tale aspetto implica la capacità di ricevere e di accogliere (che non equivalgono ad un lasciarsi trascinare passivamente o all'incapacità all'azione, ma piuttosto al "permettere di fare"), acquisita in origine attraverso una buona relazione primaria con la madre, quando la bambina si "lasciava fare" abbandonandosi a lei e alle sue cure (a cominciare dalle prime esperienze orali).
E a tal proposito, da un punto di vista sessuale, per quanto a quei tempi le conoscenze anatomiche e fisiologiche fossero ancora limitate, Freud (1905) non pensò mai che lo stadio genitale dovesse imporre alla donna cosiddetta "normale" l'eliminazione totale del ruolo e dell'importanza del clitoride nel fornire piacere, ma che piuttosto, usando una bella immagine, fosse necessaria un'integrazione delle varie sensazioni erogene del corpo (le pulsioni parziali) verso il primato vaginale (genitale), come "una scheggia di pinastro può infiammare un ceppo di legno" (p. 526). Le mortificazioni riguardo il clitoride di cui fu tanto accusato dal movimento femminista, sono legate in gran parte al materiale proveniente dalla clinica: Freud e gli analisti a venire avevano infatti osservato come nella maggior parte dei disturbi sessuali della donna, clitoride e vagina non compartecipavano al piacere durante il coito, in cui, ad esempio, l'eccitamento clitorideo porta al desiderio di penetrazione (seppur il clitoride rimanga sempre il vero responsabile dell'orgasmo [Masters e Johnson, 1966]), affinchè, da un punto di vista meramente biologico, l'orgasmo (con le contrazioni muscolari e il risucchio uterino) possa facilitare l'ingresso dello sperma attraverso la barriera del muco cervicale e condurlo così più vicino all'uovo da fecondare (Brizendine, 2006). Invece, nei quadri patologici, i due organi erano come "scissi" da un punto di vista psicosomatico, con il clitoride che accentrava tutto il piacere e la vagina che rimaneva come organo "atrofizzato" o impossibilitato nella sua funzione durante il coito (causando dolore); oppure, se la penetrazione era possibile, la donna rimaneva comunque incapace di provare qualsiasi tipo di piacere fisico (frigidità). E dopo le considerazioni precedenti, in cui si è visto come la donna possa incontrare diverse difficoltà nell'integrare nella propria femminilità il materno (identificato con la vagina e le sue e pulsioni passive-masochistiche) con il sessuale (di cui il clitoride "fallico" e le sue pulsioni attive-sadiche sono adibite al piacere), si spiega in buona parte perchè ella possa essere maggiormente soggetta a disturbi sessuali rispetto all'uomo (infatti non a caso essi si manifestano attraverso il dolore o l'assenza di piacere [Fornari, 1976]).
Tale qualità ricettiva inerente al femminile ha suggerito l'esistenza di una predisposizione nella donna ad un masochismo primario (Freud, 1924), che, nella sua presenza "normale", è ben diverso da quello nevrotico (ossia dal masochismo morale frutto di un senso di colpa autopunitivo per un'intensa aggressività rimossa) o da quello erogeno del perverso (in cui compare un'erotizzazione della distruttività, per approfondimenti...). Esso è stato concettualizzato a partire dalle esperienze che la donna si trova a vivere attraverso il proprio corpo (la deflorazione, le mestruazioni, l'aborto, il parto...), che, non prive di una certa quota di dolore, appoggiano sulla tendenza all'erotizzazione difensiva del dolore (l'aggressività a meta passiva al servizio della libido) acquisita durante il proprio sviluppo psicosessuale (Bonaparte, 1957). Processo che si può intrecciare con un'intensa dose di piacere, come accade nella vita erotica in cui l'essere penetrata dispiega potenzialmente nella donna maggiore ricchezza orgasmica (Alizade, 2006), o addirittura come succede con la comparsa di orgasmi sessuali nell'ultima fase espulsiva del parto (Fornari, 1976). E tali aspetti sono propri del femminile perchè rientrano in quel "codice materno" (Fornari, 1976) fondato sul "dare tutto e non chiedere nulla", tipico durante le cure del neonato ai primi mesi di vita, dove la dedizione e la sacrificalità richiedono alla madre una temporanea "soppressione" narcisistica di sè.
Inoltre tale aspetto del femminile è necessariamente condizionato anche dal corso che ha dovuto subire l'aggressività nello sviluppo psicosessuale della bambina, attraverso una massiccia dose di rimozione e controinvestimento a causa della delusione primaria da parte della madre, poi del rifiuto da parte del padre e infine del ritorno ambivalente verso il primo oggetto frustrante (la madre) da cui però ella continua a dipendere. Tutto ciò può lasciare come strascico forti sensi di colpa generalizzati, potenzialmente in grado di facilitare "la strada verso tutti i tentativi per alleviarlo: il masochismo, certo, ma anche le sue derive melanconiche" (Chabert, 2003, p. 132).
E dunque l'aggressività, se soppressa ulteriormente dai canoni socioculturali (che fanno della donna mansueta e remissiva la donna modello desiderabile), non avrà altre vie per potersi manifestare se non quella sintomatica (come nelle forme nevrotiche, o in quelle ancora più gravi come l'autolesionismo, i disturbi del comportamento alimentare...), o sotto forma di quell'"aggressività passiva delle donne masochiste, donne che tendono costantemente a rimproverare gli altri e a risvegliare in loro sensi di colpa mediante un comportamento basato sui sacrifici e sull'umiltà al fine di tenerli in uno stato di permanente dipendenza" (Mitscherlich, 1985, p. 171).

Inoltre, per il suo periodo preedipico più lungo rispetto a quello dei maschi, e per una maggiore difficoltà nel differenziarsi dal corpo della madre, non deve sorprendere se la donna in età adulta possa manifestare maggiori tendenze a vivere conflitti di separazione, abbandono, deficit di individuazione: motivo per cui la ricerca intensa di un uomo con cui ricreare un'intimità quasi fusionale, richiama inevitabilmente "un immaginario di pienezza e la speranza di recuperare il godimento mitico del paradiso perduto del grembo materno" (Alizade, 2006, p. 125). Invece la mancanza dell'angoscia di essere castrata (in un senso equivalente rispetto al maschio) e il suo carattere materno, possono spiegare il fatto che la morale della donna sia generalmente più orientata a mantenere l'affetto e gli equilibri da un punto di vista relazionale (e quindi rendendola più incline all'adattamento e maggiormente vulnerabile alla minaccia della perdita dell'amore oggettuale). In altri termini, piuttosto che una rigida ideologia basata su principi logico-astratti attorno ad un conflitto di diritti (come accade nel Super-Io maschile), la morale femminile sembrerebbe più attinente a problemi di natura interpersonale basati su un conflitto di responsabilità e protezione (Gilligan, 1982 [8]; Bleichmar, 1994).
Infine è chiaro che la donna non si potrà mai ridurre solo agli aspetti propri del femminile: infatti su un piano teorico di sviluppo completo (ossia genitale), ci si aspetta che l'individuo (uomo o donna) sia riuscito a raggiungere un'integrazione di tutti i vari aspetti del Sè (e quindi sia mascolini che femminili), attraverso quel tipo di soggettività unica e originale che è propria dell'individuazione (Jung, 1939 [9]).
Tuttavia, se Freud (1937) non a caso aveva visto l'invidia del fallo come "la roccia basilare" contro cui si scontra la donna (ossia la difficoltà di integrare dentro di sè il maschile, soprattutto nell'inflazione femminile masochistica/materna), si potrebbe forse capire perchè in quasi la totalità di ogni sistema socioculturale studiato dall'antropologia (Mead, 1949; Magli, 1974; Heritier, 1996), si assista, con le varie gradazioni del caso, ad una sorta di disparità "sadomasochista" tra l'uomo che solitamente detiene il potere e la donna che ne permette l'esercizio. E ciò sulla base di un ordine socioculturale patriarcale improntato all'obbedienza e alla sottomissione della donna, che non di rado arriva a svalutarne e sfruttarne le qualità a scopo narcisistico (per approfondimenti...): "proprio a causa della sua relazione all'oggetto e del suo primario bisogno di essere amata, per la donna sussiste il pericolo di identificarsi in modo acritico con le leggi maschili, con i valori e gli schemi comportamentali maschili e i pregiudizi che vi sono connessi" (Mitscherlich, 1985, p. 27).
"Le società primitive, le società barbariche e le società storiche europee e orientali mostrano tutte le varietà possibili d'istituzioni, ma in tutte, al di là delle forma della loro struttura sociale, sono sempre gli uomini ad avere il predominio, il che forse risulta tanto più evidente quanto più avanzata è la civiltà in questione. Dicendo questo non voglio essere provocatorio; forse sarebbe stato meglio se le cose non fossero state così, ma per quanto posso giudicare mi pare un fatto ormai scontato che stiano proprio in questo modo. e' vero che molte femministe hanno detto che ciò è appunto perchè alle donne è sempre stata negata l'opportunità di prendere il comando; dovremo domandarci allora come mai esse abbiano permesso che questa opportunità fosse loro negata, dato che è difficile che si sia trattato di una semplice questione di brutalità. I fatti sembrano indicare piuttosto che entrano in gioco fattori di ordine biologico, psicologico oltrechè sociologico, e che i rapporti tra i sessi possono solo essere modificati attraverso mutamenti di ordine sociale, senza che peraltro si abbiano alterazioni radicali […] E’ vero senza dubbio che in ogni società le bambine e le adolescenti si adattano, o sono costrette ad adattarsi dalle persone più anziane, all’immagine di ciò che una donna deve essere in quella particolare società; ma pretendere come fanno molti – per esempio M. Mead e S. de Beauvoir, quest’ultima nel suo notevole libro Il secondo sesso (1949) – che le differenze sociali e di temperamento tra i sessi siano semplicemente il prodotto del condizionamento culturale, è una reificazione che non spiega un bel nulla; di certo non spiega un carattere della vita sociale così universale come il ruolo direttivo assuntovi dagli uomini.” (Evans-Pritchard, 1965, p. 47) [11]
[1] Stoller R. (1968). Sex and gender, New York, Science House.
[2] Atwood G.E., Stolorow R. D. (1993). Volti nelle nuvole. Borla, Roma, 2001.
[3] Erikson E. (1964). "Womanhood and inner space", in Identity, Youth and Crisis, New York: Norton (1968), p. 261 94.
[4] Lopez D., Zorzi L. (1999). La sapienza del sogno. Masson, Milano, 1999.
[5] Gay P. (1988), Freud, una vita per i nostri tempi. Bompiani, Milano, 1988.
[6] Kestenberg J. (1968). Outside and Inside, Male and Female, in J. of the Amer. Psy. Assn, 16, p. 457 - 520.
[7] Limentani A. (1989). Il significato del transessualismo in rapporto ad alcuni concetti psicoanalitici di base. In Tra Freud e Klein. Borla, Roma, 1989.
[8] Gilligan C. (1982). Con voce di donna. Feltrinelli, Milano, 1987.
[9] Jung C.G. (1939). Coscienza, inconscio, individuazione. Bollati Boringheri, Torino, 2013.
[10] Butler J. (1999). Questioni di genere. Laterza, Bari-Roma, 2013.
[11] Evans-Pritchard (1965). La donna nelle società primitive. Laterza, Bari, 1973.
Benjamin J. (1988). Legami d'amore. Raffaello Cortina, Milano, 2013.
Bleichmar E.D. (1994). Il femminismo dell'isteria. Raffaello Cortina, Milano, 1994.
Bonaparte M. (1957). La sessualità della donna. Newton Compton, Roma, 1972.
Breen D. (1993). L'enigma dell'identità dei generi. Borla, Roma, 2000.
Brizendine L. (2006). Il cervello delle donne. Rizzoli, Milano, 202.
Brunswick R.J. (1940). La fase preedipica dello sviluppo libidico. in Chasseguet-Smirgel J. (1964). La sessualità femminile. Laterza, Roma, 1970.
Chabert C. (2003). Femminile melanconico. Borla, Roma, 2006.
Chasseguet-Smirgel J. (1964). La sessualità femminile. Laterza, Roma, 1970.
Chasseguet-Smirgel J. (1986). I due alberi del giardino. Feltrinelli, Milano, 1991.
Chodorow N.J. (1994). Femminile. Maschile. Sessuale. La Tartaruga Ed., Milano, 1995.
Cosnier J. (1987). Destini della femminilità. Borla, Roma, 1990.
Deutsch H. (1944). Psicologia della donna. 2 Vol. Boringhieri, Torino, 1977.
Fornari F. (1976). Codice materno e disturbi della femminilità. In Scritti. Raffaello Cortina, Milano, 2011.
Freud S. (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale. OSF IV, Boringhieri, T orino, 1967 - 1980.
Freud S. (1913). Il motivo della scelta degli scrigni. OSF VI, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1918). Il tabù della verginità. OSF VI, Boringhieri, T orino, 1967 - 1980.
Freud S. (1919). Un bambino viene picchiato. OSF IX, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1922). La testa di medusa. OSF IX, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1924). Il tramonto del complesso edipico. OSF X, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1924b). Il problema economico del masochismo. OSF X, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1925), «Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica tra i sessi», OSF X, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1931). Sessualità femminile. OSF XI, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1932). Introduzione alla psicoanalisi: nuova serie di lezioni, OSF XI, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1937). Analisi terminabile e interminabile, OSF XI, Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Fromm E. (1949). Sesso e carattere. In Il bisogno di credere (1963), Mondadori, Milano, 1997.
Fromm-Reichmann F. (1950). Negazione del piacere sessuale femminile. In J. Baker Miller (1974). Le donne e la psicoanalisi. Boringhieri. Torino, 1976.
Harding E. (1933). La strada della donna. Astrolabio, Roma, 1951.
Héritier F. (1996). Maschile e femminile. Il pensiero della differenza. Laterza, Bari, 2002.
Horney K. (1967). Psicologia femminile. Armando, Roma, 1980.
Jones E. (1927). Scritti sulla sessualità femminile e altri saggi. Astrolabio, Roma, 1972.
Lacan J. (1956). Libro IV. La Relazione d’oggetto. Einaudi, Torino, 1996.
Luquet-Parat C.J. (1964). Il cambiamento d'oggetto. In Chasseguet-Smirgel J. (1964). La sessualità femminile. Laterza, Roma, 1970.
Klein M. (1932). La psicoanalisi dei bambini. Martinelli, Firenze, 1969.
Laufer E. (1988). Il complesso edipico femminile e la relazione con il corpo. In Breen D. (1993). L'enigma dell'identità dei generi. Borla, Roma, 2000.
Magli, I. (1974). La donna. Un problema aperto. Vallecchi, Firenze, 1974.
Masters W.H., Johnson V.E. (1966). L'atto sessuale nell'uomo e nella donna. Feltrinelli, Milano, 1972.
McDougall J. (1964). L'omosessualità femminile. In Chasseguet-Smirgel J. (1964). La sessualità femminile. Laterza, Roma, 1970.
McDougall J. (1995). Eros. Le deviazioni del desiderio. Raffaello Cortina, Milano, 1997.
Mead M. (1949). Maschio e femmina. Il saggiatore, Milano, 1962.
Mitchell J. (1974). Psicoanalisi e femminismo. Eianaudi, Torino, 1976.
Mitscherlich M. (1985). La donna non aggressiva. La Tartaruga, Milano, 1992.
Reik T. (1961). Sesso e sentimenti nell'uomo e nella donna. Garzanti, Milano, 1976.
Riviere J. (1929). Femminilità difensiva. In Il mondo interno. Raffaello Cortina, Milano, 1998.
Salomè von L. (1915). Anale e sessuale. In La materia erotica. Scrtti di psicoanalisi. Mimesis, Milano, 2018.
Sherfey M. J. (1966). Natura ed evoluzione della sessualità femminile. In Miller J. B. (1974). Le donne e la psicoanalisi. Boringhieri, Torino, 1976.
Stoller R. (1972). Il "substrato" della mascolinità e della femminilità: la bisessualità. In Miller J. B. (1974). Le donne e la psicoanalisi. Boringhieri, Torino, 1976.
Thompson C. (1942). Pressioni culturali nella psicologia femminile. In Miller J. B. (1974). Le donne e la psicoanalisi. Boringhieri, Torino, 1976.
Torok M. (1964). Significato dell'"invidia del pene" nella donna. In Chasseguet-Smirgel J. (1964). La sessualità femminile. Laterza, Roma, 1970.
Wickler W, Seibt U. (1983). Maschile Femminile: il significato della differenziazione sessuale. Boringhieri, Torino, 1986.
Il Blog, che riceve migliaia di visualizzazioni giornaliere, contiene articoli coperti da diritti d'autore, ognuno dei quali proviene da mesi di scrupolose ed estese ricerche sul tema. Ciononostante si è scelto di divulgare tali studi in maniera completamente gratuita, senza la necessitò di affiliazioni obbligatorie ad istituzioni o riviste ed escludendo qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria. Si prega pertanto di fare buon uso di tale materiale, con l'augurio che tali contenuti possano rappresentare una fonte di stimolo per chiunque abbia interesse ad esplorare tutto ciò che riguarda quel curioso e misterioso fenomeno che è l'essere umano.