28 nov 2025Tempo di lettura: 23 min


2 nov 2025Tempo di lettura: 34 min


13 lug 2025Tempo di lettura: 5 min
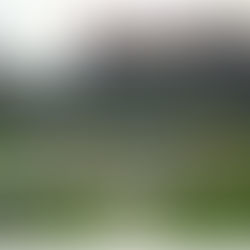

4 apr 2025Tempo di lettura: 6 min


16 mar 2025Tempo di lettura: 29 min




Versione PDF stampabile:

"Non c'è niente di più facile che condannare un malvagio, niente di più difficile che capirlo." F. Dostoevskij
Se la letteratura e il cinema di tipo crime, a partire dalle sue origini noir (per approfondimenti...), continuano ad esercitare una costante attrazione magnetica sul pubblico, deriva dal fatto che da sempre l'uomo manifesta una profonda curiosità sulla natura del male, a partire da quello che alberga dentro di sè. Già Freud (1915) infatti scriveva come dinanzi all'opera d'arte, lo spettatore fosse in grado di toccare i lati più oscuri di sè stesso identificandosi coi vari personaggi, e potere quindi vivere le medesime esperienze e sensazioni, ma al riparo dietro un mondo di finzione: "là troviamo ancora uomini che sanno morire; sì, uomini anche capaci di uccidere. (…) Nel campo della finzione troviamo quella pluralità di vite di cui abbiamo bisogno." (p. 38) In altri termini, la possibilità di venire a contatto con le storie tanto macabre e truci della cronaca nera o del mondo dell'arte permette di confrontarsi a debita distanza e senza ripercussioni nella realtà con le forze distruttive e violente che, in diversa misura, popolano la psiche di ogni uomo.
D'altronde, la figura del serial killer depravato che compie i delitti più efferati e violenti a sangue freddo, rimane ancora uno degli archetipi che più affascina l'immaginario collettivo, proprio per il fatto di possedere caratteristiche apparentemente aliene alla cosiddetta natura umana. Infatti, ciò che da un punto di vista clinico risulta curioso è il fatto che la maggior parte dei serial killer non sia affetta da psicosi (o dal controverso disturbo da personalità multipla, oggi tanto di moda al cinema): essi appartengono cioè alla schiera dei cosiddetti psicopatici, gli stessi che vivono in mezzo al resto della gente comune come predatori, parassiti, sfruttatori, mariti violenti, stalker, "colletti bianchi". Perchè la grande capacità di mimetizzarsi che li contraddistingue spiega il fatto che gli psicopatici si trovino in ogni ambito sociale, non soltanto nella popolazione carceraria di assassini e stupratori. Ciò che risulta più sconcertante è infatti la loro apparente "normalità" e correttezza sociale nella vita "diurna" di tutti i giorni: tuttavia, in realtà, come per Mr. Hyde che si cela dietro la maschera ordinaria e quotidiana del Dr. Jeckyll, essi vivono in società come "lupi mascherati" tra le altre pecore (basti pensare a T. Bundy, A. Chikatilo, J.W. Gacy, D. R. Rader...).
"Nelle leggi dell'anglosassone Edoardo il Confessore (1002-1066) si fa riferimento al wulfesheud, la testa di lupo, per indicare colui che veniva espulso dalle mura cittadine perchè reo di fatti imperdonabili e gravissimi. Il banno, cioè l'ordine di espulsione dalla città e la condanna a sopravvivere nelle foreste, errando nottetempo, rapinando e aggredendo, nutrendosi di ciò che capitava, ed esposto in ogni momento al rischio di essere ucciso da chiunque lo avesse scovato, trasformava così il bandito in un loup garou, un lupo mannaro, quella figura per metà umana e per metà ferina che ha alimentato il mito dell'orco pedofago e dell'uomo nero e che incarna il male assoluto nelle fantasie atterrite dei bambini." (G.S. Manzi in AA.VV, 2021, prefazione)
"Uccidere o essere ucciso, mangiare o essere mangiato, era la legge." (J. London)
Se già Pinel (1801 [1]) aveva osservato una forma di "mania senza delirio", e Pritchard (1835 [2]) di "follia morale", fu solo con Kraepelin (1904 [3]) che si iniziò a parlare di "personalità psicopatica" e con Birnbaum (1914 [4]) di "sociopatia". Mentre le prime analisi psicoanalitiche del carattere psicopatico sono state compiute dal lavoro pionieristico di Aichorn (1925), e poco dopo da quello di Alexander e Staub (1929) che cercarono di delineare le varie forme della psicopatia in relazione al sistema giuridico, gettando le rudimentali fondamenta dell'odierna criminologia. Giova ricordare che gli aspetti psicopatici del carattere (i cosiddetti tratti) non corrispondono necessariamente al disturbo antisociale di personalità, così come descritto dal DSM-V (il manuale scientifico maggiormente usato al mondo per la classificazione dei disturbi mentali), in quanto la psicopatia non coincide sempre con la condotta criminale: in realtà solo una parte degli psicopatici finisce in prigione (solitamente quelli più "aggressivi" rispetto a quelli di tipo "passivo-parassitario" [Kernberg, 1992]).
Dunque i tratti psicopatici possono costituire propriamente una "sindrome psicopatica" (McCord, 1964) o una "personalità antisociale" (Kernberg, 1975), oppure possono rappresentare nuclei secondari dei vari disturbi di personalità, lungo un continuum (Kernberg, 1984) dove la psicopatia si configura come il punto più basso dello spettro narcisistico (per approfondimenti...). Le caratteristiche generali della psicopatia sono comunque sempre legate ad un deficit (a volte totale) della coscienza morale (Super-Io), l'assenza di empatia (e quindi di identificazione), l'incapacità di costituire legami affettivi con gli altri (il bisogno di potere prevale su quello dell'attaccamento), un generale discontrollo degli impulsi (non sono infrequenti tossicomanie e perversioni sessuali polimorfe), ideazione paranoidea e un certo grado di perversità caratteriale (per approfondimenti...).

Forse il tratto che più caratterizza lo psicopatico è la totale assenza di empatia (la capacità di riconoscere ciò che l'altro sta provando e risponderne emotivamente): egli è infatti incapace di mettersi nei panni degli altri, se non in un senso meramente intellettuale, per lo più allo scopo di manipolare e nuocere (in quanto lo psicopatico può essere abilissimo nell'individuare e nello sfruttare le vulnerabilità dell'altro). E non si tratta di una sospensione temporanea dell'empatia (dovuto ad una particolare situazione contingente o sotto l'effetto di sostanze alteranti), nè di quelle sindromi (disturbi dello spettro autistico) che rendono assai difficile per la persona riconoscere e comprendere gli stati interni dell'altro (dove però solitamente le istanze morali rimangono intatte), bensì di un tratto cristallizzato di una configurazione permanente della personalità.
Nello psicopatico le manifestazioni emotive sono perlopiù artificiali, teatrali, superficiali e simulate al bisogno in modo manieristico: Cleckey (1941 [5]) proponeva infatti l'espressione dementia semantica per descrivere le modalità comunicative-linguistiche di questi pazienti che sono in grado di comprendere cosa fare nel modo "corretto" al momento "giusto", ma senza alcuna concordanza emotiva. Gli stati emotivi interni sono caratterizzati principalmente da un senso perenne di vuoto e di noia: l'angoscia percepita è praticamente assente (contrariamente allo psicotico che solitamente presenta confusione e intenso tormento interiore), l'ansia è ridotta ai minimi termini e "l'esperienza conscia della depressione come emozione all'interno del processo psicopatico probabilmente non esiste" (Meloy, 2002, p. 62).
L'aggressività predatoria, ossia quella volta a distruggere l'altro "a sangue freddo" (Meloy, 2002), senza nessuna esperienza emotiva conscia è il "marchio di fabbrica" della psicopatia (Meloy, 2002): contrariamente da quella di tipo difensiva/affettiva (motivata dal pericolo di una minaccia esterna e finalizzata unicamente alla sua risoluzione), essa è per lo più strumentale e non viene perciò inibita, sia per la mancanza di una coscienza morale (in grado di modulare il comportamento aggressivo), sia perchè nello psicopatico la paura come rinforzo negativo è minimo o assente. E anche quando l'aggressività si palesa attraverso manifestazioni di collera, essa tende ad essere di breve durata, conservando quella freddezza di fondo (contrariamente alle manifestazioni causate da accecanti passioni). Tale componente aggressiva, la totale indifferenza al dolore e la mancanza di tenerezza (anche per i suoi famigliari) sembrano fare assumere allo psicopatico degli atteggiamenti più tipicamente "rettiliani" che umani (Meloy, 2002) .
Nell'esercitare il dominio sull'altro, lo psicopatico è dotato di un pensiero macchiavellico: egli inganna per la soddisfazione di vedere compiuta la propria manipolazione sugli altri (Meloy, 2002), utilizzando gli strumenti che più lo caratterizzano (fascinazione, seduttività, intimidazione o violenza), spesso prendendo di mira i membri più vulnerabili della società.
Gli altri probabilmente sono una replica del mondo interno dello psicopatico, ossia una realtà popolata da oggetti potenzialmente pericolosi: ecco perchè per lui il mondo è diviso in predatori e prede, dove l'unico scopo consiste nel trarre il massimo profitto dallo sfruttamento dell'altro, che rappresenta un mero oggetto da usare per il soddisfacimento dei propri bisogni.
Le personalità psicopatiche sono incapaci di provare rimorso o anche solo preoccupazione per il dolore provocato all'altro: è infatti assente ogni tentativo di riparazione e il danno delle proprie azioni sugli altri viene sempre razionalizzato in base a regole interne che minimizzano la propria responsabilità fino a capovolgere addirittura il ruolo di vittima e carnefice. Secondo Hare (1993), l'essenza della psicopatia si può ricondurre ad un "disturbo del cervello morale": non a caso storicamente gli psicopatici venivano definiti dalla prima psichiatria "imbecilli morali".
Il conflitto che vivono è solamente tra il cieco soddisfacimento dei loro bisogni e il resto della società, in quanto le più elementari norme del vivere comune rappresentano per lo psicopatico solo delle regole assurde che limitano irragionevolmente l'espressione dei suoi appetiti (ogni ostacolo è fonte di frustrazione insostenibile): "per gli psicopatici, il mondo è come un gigantesco distributore dal quale estrarre caramelle senza mettere le monete" (Simon, 2008. p. 38).
Inoltre lo psicopatico "sembra disposto a sacrificare tutto per l'eccitazione" (McCord, 1964): egli è costantemente alla ricerca di stimoli e votato perennemente all'azione, al fine di ottenere soddisfacimento e piacere immediati. Infatti, salvo casi particolari, lo psicopatico, nonostante sia consapevole delle conseguenze dei suoi atti (conscio quindi dell'entità delle proprie azioni), si dimostra incapace nell'inibire il proprio comportamento, così che irresponsabilità e inaffidabilità si estendono ad ogni ambito di vita.
Spesso gli psicopatici appaiono di aspetto gradevole sfoggiando personalità brillanti e loquaci, non di rado mostrandosi spacconi, prepotenti, vanitosi, arroganti, senza il minimo senso di pudore, imbarazzo o vergogna. Essi hanno infatti una visione talmente inflazionata di ciò che sono (Sè grandioso) da considerarsi sempre al centro dell'universo.
Lo psicopatico inoltre è per antonomasia il maestro dell'inganno, della menzogna, della manipolazione e della truffa: anche quando viene smascherato egli rimane indifferente e continua imperterrito a far sentire l'altro nel dubbio o nell'errore, nonostante l'evidenza più schiacciante dei fatti. Pertanto lo psicopatico eccelle nell'assumere personalità fittizie o nel millantare titoli fasulli o beni di poco conto, essendo un abile impostore dotato di una straordinaria versatilità camaleontica che lo fa apparire sempre convincente. Ciononostante, lo psicopatico continua a rappresentare un personaggio bidimensionale, proprio perchè carente di tutta quella ricca complessità data dalle sfumature emotive, conflittuali e identitarie che solitamente caratterizzano le persone.
Nello psicopatico i meccanismi di difesa principali costituiscono un'esagerazione di quelli tipici della costellazione narcisistica di personalità (per approfondimenti...), in particolar modo: il diniego e il controllo onnipotente (che allontana ogni vissuto depressivo o stato di vulnerabilità), la svalutazione (accompagnata dall'euforia sprezzante e dal successo manipolativo che lo protegge dall'invidia latente), la scissione (il mondo diviso in categorie nette), l'identificazione proiettiva (la violenza deve distruggere nell'altro il materiale psichico interno che minaccia il sè grandioso). Inoltre vengono usati in modo consistente anche meccanismi difensivi più primitivi quali la proiezione paranoidea (lo psicopatico è estremamente reattivo alla minima provocazione esterna), e soprattutto la dissociazione: infatti, sebbene l'esame di realtà, per quanto distorto, solitamente venga mantenuto (ossia è intatta la capacità dell'individuo di distinguere stimoli sensoriali interocettivi da quelli esterocettivi), nel soggetto psicopatico si alternano "stati dell'Io" completamente dissociati (Kernberg, 1984).

"Chi sono i serial killer e perchè la nostra immaginazione è così colpita da quseste terribili figure? Perchè ci fanno paura, certo. Ma anche, e soprattutto, perchè sono la personificazione di quanto c'è ancora di irrazionale, di ferino, di primordiale in noi e nella nostra vita apparentemente logica e ordinata. E' il mostro che aspetta in agguato, è l'orco che si nasconde dietro le nostre esistenze quotidiane, nelle nostre strade, nelle nostre menti, nei nostri cuori". (Lucarelli, Picozzi, 2003)
Diversamente dall'assassino compulsivo che, permeato da idee persecutorie e da aspetti fortemente depressivi, mette in atto le proprie fantasie vendicative contro i suoi "persecutori" (come nel caso di omicidi casuali perpetrati in strada da qualche "maniaco", o di stragi compiute nelle scuole americane da qualche studente armato), l'FBI definisce il serial killer come "colui che commette tre o più omicidi, in tre o più località distinte, intervallate da un periodo di raffreddamento emozionale" (Douglas et al. 1992, p.13 [6]). Forse la massima forma di brutalità disumana si riscontra nella cosiddetta categoria dei serial killer di tipo sessuale, dove la psicopatia si lega con la perversione, e quindi sessualità e distruttività diventano inestricabilmente connesse (per approfondimenti...). Essi sono statisticamente rari, ma l'efferatezza del modo con cui uccidono catalizza inevitabilmente l'attenzione pubblica.
Simon (2008) distingue due tipi di serial killer sessuali (non per forza in maniera dicotomica): i sadici (che cercano il godimento supremo nella tortura e nella morte dell'altro) e i necrofili (che trovano piacere più nello smembrare e nel cannibalismo che nell'uccidere).
I sadici sessuali provocano intenzionalmente dolore fisico e psicologico allo scopo di raggiungere il massimo livello eccitazione sessuale: la vittima deve rimanere vigile e cosciente affinchè l'aguzzino possa vivere appieno la sofferenza inflitta (o il godimento sessuale diviene ridotto o impossibilitato del tutto). Secondo Fromm (1973) l'essenza del sadismo, della tortura e dello stupro trae origine dalla "passione per un controllo illimitato, pseudo-divino su uomini e cose" (p. 211), al fine di sottolineare la grandiosità e l'onnipotenza sull'altro.
Tale aspetto è condiviso anche dai necrofili, ossia quei serial killer che trovano soddisfazione sessuale solo nel momento in cui sentono di avere letteralmente un dominio totale sull'altro, per mezzo di rapporti sessuali con cadaveri (o parti di essi), esplorazione di organi dissezionati (splancofilia) e atti cannibalistici. Nei necrofili gli atti cannibalistici sono compiuti dinamicamente allo scopo di padroneggiare intense angosce orali verso l'altro (tanto bramato quanto dotato di aspetti terrifici): la morte dell'oggetto consentirebbe al necrofilo di appagare i suoi desideri fusionali-incorporativi eliminando allo stesso tempo l'angoscia di venire fagocitato (E. Kemper e G. Dahmer hanno infatti più volte dichiarato che uccidendo e mangiando le loro vittime riuscivano ad impossessarsene per sempre). Anche lo smembramento delle vittime che spesso accompagna la necrofilia si connette con tale psicodinamica, in quanto la persona nella sua totalità vivente (minacciosa) viene letteralmente smontata e parcellizzata in singole parti adibite al soddisfacimento personale (Meltzer, 1973), come feticci su cui può essere esercitato un godimento onnipotente e un trionfo sulle proprie angosce.
Essi sono ossessionati e tormentati da fantasie barocche che finiscono per materializzare concretamente sulle proprie vittime al fine di ottenere la gratificazione immaginata: già da bambini l'immaginario fantastico di alcuni futuri serial killer costituiva un particolare "rifugio della mente" (Steiner, 1993) permeato prevalentemente da contenuti violenti ed elementi mortiferi (come in G. Dahmer). Tuttavia, una volta messo in atto, l'omicidio può produrre nel killer una gratificazione talmente intensa da divenire fonte di una ricerca compulsiva che, con il passare del tempo, può richiedere variazioni operative al fine di conservare la medesima intensità del piacere originario. Infatti, attraverso i propri atti omicidi, lo psicopatico sessuale sperimenta ogni volta una sorta di estasi che lo rende dipendente da essa, al pari di un tossicomane in cerca di dosi sempre più forti e frequenti.
Molto spesso il serial killer porta con sè dalla scena del crimine dei "souvenir" che, come dei feticci intrisi di caratteristiche simboliche (Khan, 1979), gli consentono di rivivere nella propria fantasia il crimine commesso (facendogli quindi sperimentare nuovamente l'eccitazione di quegli istanti).
Siamo dunque ben lontani dalle motivazioni nevrotiche dei "delinquenti per senso di colpa" suggerite da Freud (1916) che commettono crimini mirati all'autopunizione: il più delle volte tali serial killers sono infatti organizzati, ossia pianificano nel dettaglio i loro omicidi per mettere in atto un rituale privato (la cosiddetta "firma" del serial killer), cioè un insieme di azioni e di elementi ricorrenti carichi di significati ben precisi nel loro mondo fantasmatico.
Oltre all'eliminazione di qualunque riflesso empatico, il serial killer ha sempre bisogno di disumanizzare la propria vittima al fine di proiettarne i suoi tratti rinnegati e inaccettabili: egli, inconsciamente disgustato da sè stesso, fa assumere all'altro le caratteristiche di parti intollerabili e soverchianti di sè, per poi, solo temporaneamente, distruggerle (e non a caso le sue vittime sono spesso persone socialmente fragili, vulnerabili, ingenue, deboli psicologicamente). Perchè "i predatori sono inconsciamente spaventati di essere le vittime della predazione a causa del ciclo proiettivo e introiettivo del proprio materiale sadico e aggressivo" (Meloy, 2002, p. 165), così come "il grado di atrocità della violenza agita sulla vittima tradisce l'intensità dell'affetto dissociato" (ibid., p. 60). Ogni omicidio della vittima (sulla quale agisce l'identificazione proiettiva delle parti del sè che sono state dissociate) è finalizzato a rafforzare i sentimenti di onnipotenza del serial killer (Horney, 1945), il quale, a volte, rende addirittura spettatrice la società stessa dei suoi atti violenti e brutali, al fine di attirare ulteriormente l'attenzione sulla grandiosità del proprio sè (come nei casi irrisolti di Zodiac o di Jack lo Squartatore).
A volte stati psicotici (supportati prevalentemente da deliri paranoidei o da accessi maniacali) vengono "impiegati" regressivamente per facilitare e amplificare gli impulsi sadici e violenti (si pensi a R.T. Chase): cosicché l'atto predatorio diviene una modalità per eliminare angosce annichilenti (psicotiche) provenienti da oggetti persecutori interni e la mania (spesso ricercata attraverso droghe psicostimolanti) un trionfo su di essi (Balier, 1996). .
Il mondo dell'assassino seriale è tutto, però fuorchè un mondo meraviglioso, e forse non è neppure misterioso. Rapito dal suo bisogno di sentirsi dio in un mondo di oggetti inanimati da plasmare secondo i propri perversi bisogni generati all'interno di relazioni traumatiche nell'infanzia, è obbligato, in una costante coazione a ripetere, a ingannare se stesso rimettendo in scena i propri traumi per sentire di padroneggiarli. La sua onnipotenza è un mero bluff di fronte alla miseria del suo mondo interno, alla sua incapacità di provare amore ed empatia, alla sua impossibilità di essere un essere umano in mezzo agli altri esseri umani." (AA.VV. 2021, p. 117)

Negli psicopatici si sono osservate alcune anomalie biologiche: l'intero circuito cerebrale della modulazione dell'empatia (un'interconnessione complessa che coinvolge dieci centri nel cervello) risulta compromesso (Baron-Cohen, 2011), con una ridotta attività dei neuroni specchio (ad esempio si è riscontrata una bassa reattività quando lo psicopatico guarda persone in difficoltà o scene violente che mostrano la sofferenza altrui). Inoltre registrazioni biomediche (Raine, Glenn, 2014) hanno evidenziato ridotte risposte autonomiche associate alla paura e all'ansia (ad esempio dinanzi a minacce ed eventi aversivi); test sul linguaggio hanno mostrato come gli psicopatici siano privi di alcune delle componenti affettive proprie del linguaggio e di come abbiano difficoltà a tradurre in parole le emozioni (considerate mere astrazioni concettuali); ricerche di neuroimaging (Raine, Glenn, 2014) hanno mostrato anomalie da parte della corteccia orbitofrontale e dell'amigdala, accompagnate da disregolazioni ormonali (alti livelli di testosterone a scapito di bassi livelli di cortisolo).
Tuttavia si ricorda come sia un grossolano errore confondere la biologia con l'ereditarietà genetica, in quanto non si può sapere se tali anomalie biologiche siano innate o frutto dell'influenza ambientale nei primi anni di vita, dato che l'ambiente è in grado di influenzare i sistemi biologici nella struttura e nel funzionamento a partire dalla vita fetale dell'ambiente uterino. Ad esempio si è osservato come esperienze precoci altamente traumatiche ripetute nel tempo possano influenzare il modo in cui il cervello si sviluppa, contribuendo ad innescare tratti psicopatici e comportamenti antisociali (Meloy, 2002).
Già Winnicott (1956) aveva evidenziato la presenza di importanti "deprivazioni" ambientali e affettive all'origine del comportamento antisociale nel bambino e il carattere fondamentalmente antidepressivo di ogni atto delinquenziale. Anche A. Freud e D. Burlingham (1972) avevano osservato aspetti antisociali e lacune morali in bambini di scuole infantili inglesi che erano stati separati dalle famiglie durante la guerra. Mentre altre voci psicoanalitiche (Aichorn, 1925; Greenacre, 1952; Meloy, 2002) hanno suggerito come i tratti psicopatici del bambino siano fondamentalmente caratterizzate dal fallimento di qualunque forma di internalizzazione (identificazione) di figure di riferimento durante l'infanzia.
Figure di spicco nel campo della ricerca e del trattamento della psicopatia sottolineano invece come la componente genetica sia rilevante (Hare, 1993), adducendo come prove gli studi sui gemelli omozigoti e sui bambini adottati (provenienti da genitori antisociali), e il fatto che i tratti della psicopatia si manifestano molto precocemente nel bambino. Infatti, sebbene non tutti i bambini che diventeranno psicopatici presentino sempre i tre comportamenti tipici (piromania, enuresi notturna e crudeltà verso gli animali; MacDonald, 1963 [7]), almeno nel 40% dei casi il disturbo antisociale di personalità nell'adulto è preceduto da un disturbo della condotta in età infantile (Simon, 2008). E in generale è abbastanza raro che durante l'infanzia non compaia qualche precursore del quadro psicopatico, così come la presenza di comportamenti antisociali durante l'adolescenza (furti, aggressioni, uso di sostanze, vandalismi...).
"E' vero che l'infanzia di alcuni psicopatici è stata caratterizzata da deprivazione materiale ed emotiva e da violenza fisica, ma per ogni adulto psicopatico che proviene da un ambiente problematico ce n'è un altro nella cui vita famigliare, apparentemente, non sono mancati affetto e cure, e i cui fratelli sono persone normali e coscienziose, capaci di prendersi cura degli altri. Inoltre, molti di coloro che hanno avuto un'infanzia orribile non diventano psicopatici o spietati assassini." (Hare, 1993, p. 22)
I dati relativi alle biografie dei serial killer più efferati invece sembrano avere concordanze più nette, in quanto "si scopre che prima di divenire carnefici, molti serial killer sono stati vittima di contesti famigliari inadeguati e maltrattanti" (AA.VV, 2021, p. 62), hanno subito abusi sessuali, gravi trascuratezze o "orrende violenze famigliari" durante l'infanzia (Simon, 2008). Ciò spiegherebbe in larga parte due importanti processi che avvengono nella psicodinamica del serial killer sessuale: l'identificazione con l'aggressore (la vittima si identifica con l'autore degli abusi) e l'erotizzazione (sessualizzazione) del trauma. Egli cioè non solo agisce da protagonista ciò che in passato ha dovuto subire dal genitore carnefice (ribalta cioè il vissuto traumatico che la dissociazione ha eliminato dalla coscienza per permettere a suo tempo la sopravvivenza psichica), ma converte inoltre l'esperienza angosciosa in fonte di eccitamento erotizzando la situazione dolorosa (il godimento perverso), al fine di padroneggiare l'impatto distruttivo che gli eventi infantili hanno avuto sulla sua psiche. In altri termini, attraverso tale rovesciamento l'omicida psicopatico domina l'altro al fine di dimostrare continuamente a se stesso di poter riuscire a controllare i vissuti di impotenza delle sue esperienze infantili terrificanti: "sulla base di questo meccanismo proiettivo, i serial killer avrebbero la possibilità di controllare i propri oggetti interni agendo direttamente su coloro che ne diventano i rappresentanti simbolici. Aggredire l'altro significa dunque aggredire gli oggetti sadici e annichilenti del proprio mondo interno." (AA.VV. 2021, p. 82).
Tali vissuti totalmente dissociati dal sè contribuiscono a spiegare perchè spesso i serial killers parlano dei loro impulsi come qualcosa di estrano alla propria personalità, che preme per essere messo in atto in modo coercitivo e, a volte, al di fuori del loro controllo: "i ricordi e le emozioni soverchianti (dissociati) connessi con eventi infantili altamente traumatici subiti in maniera passiva, si ripropongono cioè nella vita adulta in maniera attiva.
In tal senso, paradossalmente "l'omicidio seriale può essere visto come una spasmodica ricerca di autocura di fronte alla frammentazione narcisistica" (ibid., p. 105), in quanto "la distruzione della vittima rappresenta la distruzione di ciò che è stato traumatico" (ibid., p. 109).
"Ero talmente dominato dall'ossessione compulsiva, irrefrenabile di fare ciò che facevo che qualsiasi sentimento di repulsione veniva neutralizzato." (G. Dahmer, in Simon, 2008, p. 294)
Dunque, interpretando tali dati secondo i modelli attuali (Raine, 2002 [13]; Zubin J. & Spring B. (1977) [14]), ma già intuiti da Freud (1895) più di un secolo fa, il "risultato" personologico dello psicopatico (come in altri quadri psicopatologici) è ottenuto dalla complementarietà tra biologia e ambiente (diatesi-stress), dove "il legame tra comportamento antisociale e fattori di rischio biologici sarà più debole, anzichè più forte, negli ambienti domestici avversi perchè i fattori di rischio sociali di crimine mascherano i contributi biologici. [...] Tuttavia, se un individuo proviene da un buon ambiente domestico è antisociale, è più probabile che ciò sia dovuto ai fattori di rischio biologici." (Raine A., Glenn A.L., 2014, p. 130). In tal senso quindi l'interazione tra la componente innata della persona con l'ambiente circostante dà origine alle varie forme di quel continuum narcisistico (Kernberg, 1984), in cui probabilmente, nel serial killer, un ambiente fortemente patogeno non fa che detonare sensibilmente tendenze psicopatiche ereditarie.
"I bambini maltrattati che da adulti diventano violentatori sono quelli che, sentendosi martirizzati, crescono pensando a una vendetta e credono sia loro diritto far del male agli altri come se ne è fatto a loro. In questi soggetti, la compassione si è spenta: il mondo è una giungla nella quale devono ferire o sfruttare gli altri per sopravvivere." (Simon, 208, p. 67)

"La legge, almeno teoricamente, opera sull'assunto di un contrasto assoluto, uno schema o così o così, secondo il quale uno deve dichiarare i pazienti totalmente insani (irresponsabili) o totalmente sani (responsabili). Questo, come sostanzialmente ammetteranno tutti gli psichiatri, non concorda con la realtà nè può condurre ad un'azione equa per tutti." (Cleckey, in McCord, 1964 p. 179)
Quando si ha a che fare con la psicopatologia dal punto di vista forense, ci si imbatte in questioni spinose come il grado di responsabilità di un'azione (la capacità di intendere e di volere), se la gestione dello psicopatico spetti al sistema giudiziario o ai professionisti della salute mentale, e quali possano essere le migliori soluzioni per i comportamenti antisociali. Di fatto la legge chiede continuamente agli psichiatri forensi di sapere se l'imputato sia pazzo o malvagio (perlomeno nel momento in cui commetteva il crimine), in quanto, come si è visto, sebbene gli psicopatici possano presentare anche gravi sindromi psicotiche (come nei celebri casi di Ed Gein o di D. Berkowitz), solitamente nella psicopatia è conservato un esame di realtà che manca nelle schizofrenie (e di solito, contrariamente dagli psicopatici, i crimini degli psicotici sono spesso compiuti in maniera disorganizzata e caotica). Motivo per cui è notoriamente risaputo come gli psicopatici simulino spesso di essere affetti da qualche grave disturbo mentale per evitarsi l'ergastolo o la pena di morte (come accadde nel caso di K. Bianchi).
Tuttavia, come sottolineato da alcuni autori (Glenn e Raine, 2014), se è vero che lo psicopatico conserva la capacità cognitiva di discernere il bene dal male (la consapevolezza dell'esistenza di certe regole e delle conseguenze di certe azioni), non si può dire che egli sia altrettanto capace da un punto di vista psicologico e, a quanto pare anche biologico, proprio perchè carente di quelle istanze morali e di quelle funzioni empatiche che contribuiscono ad inibire la messa in atto di comportamenti violenti.
Eppure giustamente il sistema giudiziario avanza come obiettivo primario quello di proteggere la società dal rischio che il soggetto possa nuocere ancora, e chiede quindi alla psichiatria forense di valutare la pericolosità sociale della persona (e di solito gli psicopatici commettono il doppio dei reati violenti rispetto agli altri delinquenti fuori e in prigione [Hare, 1993]). Perchè di fatto il legame tra psicopatia e recidiva è altissimo: siccome lo psicopatico non impara mai la lezione proprio perchè non ha introiettato alcuna forma di restrizione sociale e morale, la punizione (come quella impartita in forma carceraria) è priva di qualsiasi forma correttiva una volta in cui egli torna in libertà. Motivo per cui le istituzioni carcerarie che ospitano i criminali potrebbero rappresentare i setting ideali per trovare soluzioni riabilitative per quella piccola ma letale fascia di popolazione che, nelle sue diramazioni antisociali, si stima rappresentare per la società un costo maggiore rispetto ad ogni altro costo in termini comportamentali e di salute (Glenn e Raine, 2014).
Inoltre, in un contesto socioculturale come quello attuale che enfatizza in modo esasperato il narcisismo e il successo (per approfondimenti...), alcuni psicopatici non sfociano in atti devianti veri e propri (o non vengono scoperti), mentre altri, per questioni di buona sorte, sono riusciti a costruire i propri successi (ottenendo lodi e ammirazione) proprio grazie ai loro tratti psicopatici. D'altronde non è un caso se Schneider (1923) sosteneva che lo psicopatico, più che malato, fosse prima di tutto anormale, nel senso di intendere il problema soprattutto nel modo in cui la "personalità abnorme" si pone in relazione con il resto della società.
"Molti psicopatici non vanno mai in prigione o in qualche altra struttura di detenzione. Sembrano andare avanti ragionevolmente bene come avvocati, medici, psichiatri, accademici, mercenari, poliziotti, capi religiosi, militari, uomini d'affari, scrittori, artisti, personaggi dello spettacolo, e così via, senza infrangere la legge, o almeno senza essere scoperti e condannati. Questi individui restano comunque egocentrici, insensibili e manipolativi, come lo psicopatico criminale medio: tuttavia, l'intelligenza, l'ambiente famigliare, le competenze sociali e le circostanze permettono loro di costruire una facciata di normalità e di ottenere quello che vogliono con una relativa impunità. " (Hare, 1993, p. 134)
Da un punto di visto terapeutico, le terapie farmacologiche e psicoterapiche (anche in diversi contesti, come nelle comunità terapeutiche) sono risultate di scarsa efficacia per lo psicopatico. Molti autori ritengono infatti che la psicoterapia per gli psicopatici sia un ossimoro, per il fatto che questi individui non accettano mai il ruolo di paziente, non pensano di avere problemi psicologici o emotivi, e non vedono alcun motivo o necessità per cambiare ciò che sono. Sebbene alcuni psicopatici migliorino con l'avanzare dell'età, sono molto poche le probabilità di produrre cambiamenti significativi, profondi e duraturi nelle personalità psicopatiche: infatti ,anche quando si osservano cambiamenti, il più delle volte essi sono solo "epidermici" (Greenacre, 1952), o comunque scompaiono altrettanto velocemente come si sono presentati. Le terapie ambientali in età evolutiva (Aichorn, 1925; Redl e Wineman, 1951; McCord, 1964) hanno fornito qualche risultato più incoraggiante, ma di certo non sufficientemente confortante. Una prognosi più favorevole si delinea invece in quei disturbi di personalità (border, narcisismo maligno, paranoide) in cui la psicopatia è presente solo come tratto secondario di personalità (Kernberg, 1992), in quanto "il grado di patologia del Super-Io del paziente è un indicatore prognostico del successo psicoterapeutico" (Meloy. 2002, p. 217).
Con poche eccezioni, le forme tradizionali di psicoterapia, compresi la psicoanalisi, la terapia di gruppo, la terapia centrata sul cliente e lo psicodramma, si sono dimostrate inefficaci nel trattamento della psicopatia. Non hanno fatto molto meglio le terapie mediche, come la neurochirurgia, l'elettroshock e l'uso di vari farmaci. (Hare 1993, p. 219)

"Se i desideri fossero cavalli, tirerebbero i carri funebri dei nostri più cari amici e dei nostri parenti più stretti." (T. Reik)
Nel suo celebre saggio H. Arendt (1963) cercò di capire come fosse stato possibile un fenomeno di crudeltà di così vasta portata durante il regime nazista: prendendo come emblema il gerarca nazista Adolf Eichmann (uno dei principali "burocrati" dell'Olocausto), H. Arendt volle mostrare come quell'uomo non fosse nè folle nè diverso da tutti gli altri, ma soltanto un individuo come tutti gli altri all'interno però di un ambiente socioculturale ben architettato per l'esecuzione del genocidio. D'altronde le stesse guardie naziste che di giorno uccidevano e torturavano a sangue freddo prigionieri ebrei, una volta in cui rincasavano la sera per fare ritorno dalle proprie famiglie, baciavano le proprie mogli, ascoltavano musica classica in salotto e leggevano una favola ai loro figlioletti prima di metterli a dormire (e già questo potrebbe dimostrare quanto fosse massiccio in tali individui l'uso della dissociazione).
Questa tesi si associa spontaneamente con altri celebri studi svolti dalla psicologia sociale: S. Asch (1955) [8] dimostrò infatti come la pressione al conformismo possa far sì che le persone arrivino ad affermare che una linea sia più lunga solo perchè tuti gli altri lo sostengono, nonostante la percezione possa mostrare palesemente il contrario; S. Milgram (1974 [9]) mostrò sperimentalmente come gente comune accettasse di infliggere ad altri individui sofferenze fisiche attraverso shock elettrici (anche mortali!) solamente per "obbedienza all'autorità"; P. Zimbardo (2007 [10]), nel suo celebre esperimento della "prigione di Stanford", fece emergere ogni sorta di crudeltà in studenti inseriti in una prigione simulata, ai quali era stato assegnato casualmente il ruolo di prigionieri e secondini. Le stesse dinamiche delle folle (Freud, 1921) illustrano come le persone, una volta in cui diventano massa, agiscano con modalità che neppure avrebbero immaginato come singoli individui: infatti secondo Freud (1929) è solo per l'esistenza della civiltà (e quindi per il suo derivato intrapsichico, il Super-Io) se l'uomo ha saputo imbrigliare le proprie passioni più primitive che portano allo stupro, all'omicidio e all'incesto. Anche il romanzo del premio Nobel W. Golding (1954) ha sottolineato come possano sprigionarsi violenza e crudeltà proprio nel momento in cui vengono a mancare i freni inibitori della struttura sociale. Di fatto Freud (1925) sosteneva l'esistenza di una "pulsione di morte" insita nella natura dell'uomo, ovvero quella strada contrapposta ad Eros (la pulsione di vita), che procede in maniera regressiva (basata cioè sulla distruttività - introversa/nevrotica/psicotica o estroversa/sadica/psicopatica -), anch'essa finalizzata a ricreare lo "stato elazionale primario" (Grunberger, 1971), ossia la ricongiunzione simbolica con l'antico stato nostalgico di unione con la madre (per approfondimenti...).
L'uomo non può vivere come una cosa, come un dado gettato dal bicchiere. Soffre intensamente quando viene ridotto al livello di macchina per mangiare o per moltiplicarsi, anche se ha tutta la sicurezza che desidera. L'uomo è alla ricerca del drammatico, dell'eccitante; se non riesce a ottenere una soddisfazione di livello superiore, crea per se stesso il dramma della distruzione." (Fromm, 1973, p. 25)
Tuttavia Cesarini (2004 [11]), nel suo dettagliato studio biografico su Eichmann, ha evidenziato come in realtà il burocrate nazista non fosse affatto solo un semplice esecutore di ordini, bensì un sadico particolarmente "creativo" nel commettere i propri crimini, ben distante da una presunta normalità. Anche le analisi effettuate da Fromm (1973) su H. Himmler, le testimonianze di Gilbert (1947) - lo psicologo del carcere di Norimberga - sui gerarchi nazisti catturati dagli USA (Goering, Keitel, Kaltenbrunner, Frank, Streicher...), e lo studio svolto da Dick (1972 [12]) sulle personalità dei nazisti e del loro background storico, hanno messo in rilievo come i nuclei sadici, psicopatici e paranoidi, già presenti in tali soggetti, aspettassero solo l'occasione propizia per trovare piena espressione in situazioni facilitanti (come i campi di sterminio che addirittura premiavano tali comportamenti), per poi ritornare "quiescenti" durante e dopo il periodo di reclusione.
Inoltre Fromm (1973), riguardo agli sperimenti sopracitati di Milgram e di Zimbardo, ha sottolineato come non tutti i partecipanti ubbidirono ciecamente all'autorità cedendo al conformismo sociale, e che comunque la maggior parte di essi avevano vissuto con molto conflitto, ansia e agitazione il fatto di infliggere punizioni, umiliazioni e dolore agli altri. Per cui, se è vero che il contesto specifico non fece altro che rivelare il sadismo e la crudeltà già presenti in certi individui, è altrettanto vero che in altri soggetti, seppur inseriti in una situazione propizia, questo fenomeno non avvenne affatto. Anche i resoconti di Bettelheim (1960) sulla vita nei campi di concentramento hanno mostrato come, nonostante le condizioni così estreme e disumanizzanti, continuasse a mantenersi una profonda forma di umanità tra la maggior parte dei prigionieri.
Cos'è dunque che rende "malvagio" un uomo?
Alla fine tale problema, che ha tanto arrovellato i pensatori di ogni tempo, può trovare soluzione nel momento in cui si considera il rapporto tra organizzazione di personalità e senso morale dell'individuo (costruito in gran parte evolutivamente dalle identificazioni infantili), in quanto se è vero che il "male" alberga la natura di ogni uomo (dato che le forme patologiche dell'aggressività - sadismo e masochismo -, e un certo grado di odio e di distruttività fanno parte dell'universale esperienza umana), la sua manifestazione è profondamente mediata dal cosiddetto carattere individuale più che da uno schema istintuale innato (e l'uomo è l'unico mammifero che prova piacere ad uccidere e torturare). E tale carattere è sì frutto della genetica, ma anche di tutte le esperienze passate che hanno plasmato nella persona una sorta di "seconda natura" (Fromm, 1973), proprio come una "sindrome" sviluppata successivamente per adattarsi alle richieste ambientali.
Dunque, ciò che rimane solo come mera fantasia sotto la presenza vigile di un'istanza morale più o meno strutturata (il cosiddetto Super-Io), si può facilmente trasformare in azione concreta nelle basse organizzazioni di personalità, laddove sono inficiate le capacità morali ed empatiche della persona (Kernberg, 1975). Utilizzando un paragone letterario, se è vero che tutti i fratelli ne I fratelli Karamazov (Dostoevskij, 1880) nutrono desideri parricidi per diverse ragioni (Freud, 1927), solo Smerdijakov (quello con i tratti psicopatici più spiccati) tradurrà in azione ciò che gli altri fratelli sono riusciti a confinare nella fantasia.
In altri termini, se è vero che "non ci sono santi" tra gli uomini e che "ciò che i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno" (Simon, 2008), è altrettanto vero che alcune fantasie di certi serial killer o le azioni di certe personalità particolarmente distruttive, ossia "necrofile" (Fromm, 1973), vanno ben al di là delle semplici fantasie delle "gente comune" o delle organizzazioni più "alte": d'altronde "la realtà della personalità antisociale è l'incubo della persona normale; la realtà della persona normale è l'incubo dello psicopatico" (Kernberg, 1992, p. 98).
Ecco perchè, come sosteneva già Eraclito, in un certo senso il carattere della persona rappresenta il suo destino (quel destino che la terapia psicoanalitica tenta faticosamente di cambiare), e di fatto lo psicopatico fallisce continuamente da un punto di vista esistenziale (Hafner, 1961), in quanto, essendo incapace di realizzare se stesso e di stringere qualsiasi tipo di legame intimo, non riesce a trovare posto nel mondo: la mancanza di qualsiasi forma ideale a cui aspirare, l'impossibilità di apprendere dall'esperienza e il bisogno di gratificazioni libidiche o aggressive immediate, lo intrappolano in un presente arido e senza senso da cui difficilmente potrà uscire.
"Come nella prima legge della termodinamica, che spiega la conservazione dell'energia, il nostro lato oscuro non può essere creato nè distrutto. Può solo mutare di forma. Può essere mantenuto a livello del pensiero e delle emozioni, può essere incanalato in attività utili, o può trovare sfogo in atti distruttivi." (Simon, 2008, p. 16)
[1] Pinel P. (1801). Trattato medico-filosofico sull'alienazione mentale. ETS, Pisa, 1987.
[2] Pritchard J. C. (1835). A treatise on insanity and other disorders affecting the mind. Sherwood, Gilbert, and Piper.
[3] Kraepelin E. (1904). Trattato di psichiatria. Vallardi, Milano, 1906.
[4] Birnbaum K. (1914). Die psychopathischen Verbrecker. Thieme, Leipzig.
[5] Cleckley, H. (1941). The Mask of Sanity. St. Louis, C.V. Mosley.
[6] Douglas J., Burgess A., Burgess A. (1992). Crime Classification Manual. Un sistema standardizzato per indagare e classificare i crimini violenti. Edi Ermes Ed., Milano, 2016.
[7] MacDonald J. (1963). The threat to kill. American Journal of Psychiatry 120:125.130.
[8] Ash S. (1955). "Opinions and social pressure." In Scientific American, 193, pp. 31-35.
[9] Milgram S. (1963). Obedience to Authority: An Experimental View. Harper and Row, New York, NY.
[10] Zimbardo P. (1972). L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?. Raffaello Cortina, Milano, 2008.
[11] Cesarini D. (2004). Eichmann: His Life and Crimes. Heinemann, London.
[12] Dicks H.V. (1972). Licensed Mass Murder: a Socio-Psychological Study of Some SS Killers. Basic Books, New York.
[13] Zubin J. & Spring B. (1977). Vulnerability: a new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86: 103-126.
[14] Raine A. (2002). Biosocial studiesof antisocial and violent behavior in children and adults: A review. Journal of Abnormal Child Psychology, 30:311-26.
AA.VV. (2021). Psicodinamica del serial killer. Fioriti Ed. Roma.
Aichhorn A. (1925). Gioventù disadattata. Città Nuova Editrice, Roma, 1978.
Alexander F., Staub H. (1929). Il delinquente, il suo giudice, e il pubblico. Giuffré, Milano, 1948.
Arendt H. (1963). La banalità del male. Feltrinelli, Milano, 1964.
Baron-Cohen S. (2011). La scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà. Raffaello Cortina. Milano, 2012.
Balier C. (1996). Psicoanalisi dei comportamenti sessuali violenti. Centro Scientifico Editore, Torino, 1998.
Bettelheim B. (1960). Il prezzo della vita. Adelphi, Milano, 1965.
Freud A, Burlingham D. (1972), Bambini senza famiglia, Astrolabio, Roma, 1978.
Freud S. (1895), A proposito di una critica della "nevrosi d'angoscia", In Opere vol. II. Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1915), Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, In Opere vol. VIII. Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1920). Al di là del principio di piacere. In Opere vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1916). Alcuni tipi di carattere tratti dal lavoro psicoanalitico. In Opere vol. XI, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell'Io. In Opere vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1927). Dostoevskij e il parricidio. In: Opere, vol. X, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Freud S. (1929). Il disagio della civiltà. In Opere vol. X, Bollati Boringhieri, Torino, 1967 - 1980.
Fromm E. (1973). Anatomia della distruttività umana. Mondadori, Milano, 1975.
Gilbert G. (). Nelle tenebre di Norimberga: parla lo psicologo del processo. SEI, Torino, 2005.
Golding W. (1954). Il signore delle mosche. Mondadori, Milano, 1992.
Greenacre P. (1952). La coscienza dello psicopatico. In Trauma, crescita, personalità. Raffaello Cortina, Milano, 1986.
Grunberger B. (1971), Il narcisismo. RCS Libri, Milano, 2007.
Hafner H. (1961). Psicopatici. Fioriti Ed. Roma, 2011.
Hare. R. (1993). La Psicopatia. Astrolabio, Roma, 2009.
Horney K. (1945). I tratti sadici. In I nostri conflitti interni. Martinelli Ed., Firenze, 1971.
Kernberg O. (1975). Sindromi marginali e narcisismo patologico. Bollati Boringhieri, Torino, 1981.
Kernberg O. (1984). Disturbi gravi della personalità. Bollati Boringhieri, Torino, 1987.
Kernberg, O. (1992), Aggressività, disturbi della personalità e perversioni. Raffaello Cortina, Milano, 1993.
Khan M. M. R. (1979), Le figure della perversione. Boringhieri, Torino, 1982.
Lucarelli C, Picozzi M. (2003). Serial Killer. Storie di ossessione omicida. Mondadori, Milano.
McCord W. (1964). Lo psicopatico. Saggio sulla mente criminale. Ubaldini, Roma, 1970.
Meloy J.R. (2002). La mente psicopatica. Fioriti Ed., Roma, 2017.
Meltzer D. (1973), Stati sessuali della mente. Armando, Roma, 1975.
Raine A., Glenn A.L. (2014). Psicopatia. Fioriti Ed., Roma, 2016.
Redl F., Wineman D. (1951). Bambini che odiano. Bollati Boringhieri, Torino, 1974.
Schneider K. (1923). Le personalità psicopatiche. Fioriti Ed., Roma, 2008.
Simon R. I. (2008). I buoni lo sognano i cattivi lo fanno. Raffaello Cortina. Milano, 2013.
Steiner J (1993), I rifugi della mente. Boringhieri, Torino, 1996
Winnicott D.W. (1956). Il bambino deprivato: le origini della tendenza antisociale. Raffaello Cortina, Milano, 1987.
M - Il mostro di Düsseldorf (1931), di F. Lang
L'occhio che uccide (1960), di M. Powell
Landru (1963), diC. Chabrol
Arancia meccanica (1971), di S. Kubrick
La rabbia giovane (1973), di T. Malick
Henry, pioggia di sangue (1986), di J. McNaughton
Velluto blu (1986), di D. Lynch
Wall Street (1987), di O. Stone
Misery non deve morire (1990), di R. Reiner
Il silenzio degli innocenti (1991), di J. Demme
Cape Fear (1991), di M Scorsese
Assassini nati (1994), di O. Stone
Seven (1995), di D. Fincher
American Psycho (2000), di M. Harron
Ichi the Killer (2001), di T. Miike
Gacy (2003), di C. Saunders
Evilenko (2004), di D. Grieco
A sangue freddo (2005), di B. Miller
Criminal minds (2005-2020), serie TV ideata da J. Davis
Profumo - Storia di un assassino (2006), di T. Tykwer
Non è un paese per vecchi (2007), di J. e E. Cohen
Funny Games (2007), di M. Haneke
Mr. Brooks (2007), di B. Evans
Bronson (2008), di N.W. Refn
Killer Joe (2011), di W. Friedkin
Lo sciacallo (2014), di D. Gilroy
Gone girl (2014), di D. Fincher
True detective (2014), serie TV ideata da N. Pizzolatto
Mindhunter (2017), serie TV
La casa di Jack (2018), di L. von Trier
Il mostro di St. Pauli (2019), di F. Akin
Jocker (2019), di T. Phillips
Ted Bundy (2019), di J. Berlinger
Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (2022), miniserie TV
Il Blog, che riceve migliaia di visualizzazioni giornaliere, contiene articoli coperti da diritti d'autore, ognuno dei quali proviene da mesi di scrupolose ed estese ricerche sul tema. Ciononostante si è scelto di divulgare tali studi in maniera completamente gratuita, senza la necessitò di affiliazioni obbligatorie ad istituzioni o riviste ed escludendo qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria. Si prega pertanto di fare buon uso di tale materiale, con l'augurio che tali contenuti possano rappresentare una fonte di stimolo per chiunque abbia interesse ad esplorare tutto ciò che riguarda quel curioso e misterioso fenomeno che è l'essere umano.
Commenti